Martha
Operator, number, please
It’s been so many years
Will she remember my old voice
While I fight the tears?
Hello, hello there, is this Martha?
This is old Tom Frost
And I am calling long distance
Don’t worry ’bout the cost
‘Cause it’s been forty years or more
Now, VV, please recall
Meet me out for coffee

Appartengo – ma potrei dire, credo, apparteniamo in tanti – a una generazione di assaggiatori che ha scoperto tardi la Romagna. Ci siamo perlopiù formati nella convinzione che si dovesse andare altrove per bere bene. Una convinzione che a un certo punto prese piede anche tra i produttori locali, rassegnati al peggio. Per fortuna le cose non stanno più così, c’è la volontà e l’ostinazione di esserci, di farsi sentire, di marcare un’impronta, di fare attrito con tutto ciò che c’è: atteggiamento positivo che se non fa smettere di piovere apre almeno l’ombrello sulla testa degli interpreti più volenterosi.
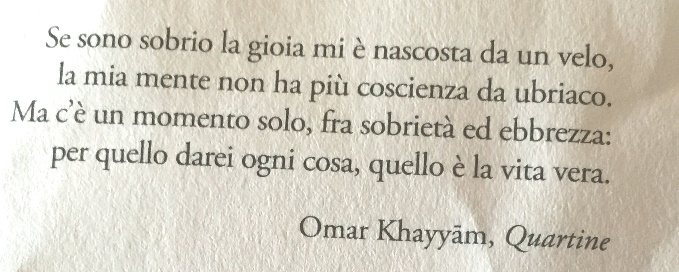
È indiscutibile che qualche vino buono la Romagna l’abbia sempre prodotto, anche nel passato meno recente, ma si trattava di luci episodiche che non spostavano l’attenzione degli operatori su una regione grande, prolifica e fortemente penalizzata da logiche mercantili.
Di recente l’interesse degli appassionati appare per fortuna più tangibile e dunque mi domando: da quando abbiamo compreso che fosse doveroso un sguardo nuovo sulle vicende del vino romagnolo? E quali sono le ragioni? Ecco, se la risposta deve riguardare solo il valore delle referenze nei cataloghi aziendali, gli osservatori avranno certamente apprezzato la continuità di rendimento di tanti vignaioli negli ultimi cinque, sei anni, con una diffusione di buone bottiglie mai così ampia su tutto il territorio (ad eccezione del Riminese, ancora piuttosto sonnolento). Se invece la svolta si può collegare anche a fattori laterali alla produzione, allora personalmente considero decisivo il primo tentativo di mappatura della regione messo agli atti da Giavedoni e Melandri una dozzina d’anni fa. Un documento pubblicato sulla rivista mensile del Gambero Rosso che approfondiva alcuni temi già sfiorati da Gianfranco Bolognesi nel suo ormai introvabile I Vini del Sole Romagna (curato da Cesare Pillon per Editori del Sole): un testo che per la prima volta portò alla luce gli aspetti più intimi delle vallate, delle quinte collinari e dei terreni romagnoli, stimolando un inconsueto interesse mediatico sulla regione e anticipando di parecchio sia le Sottozone Ufficiali del Romagna Sangiovese (2011) che la successiva Carta di Enogea (Alessandro Masnaghetti Editore, 2012)
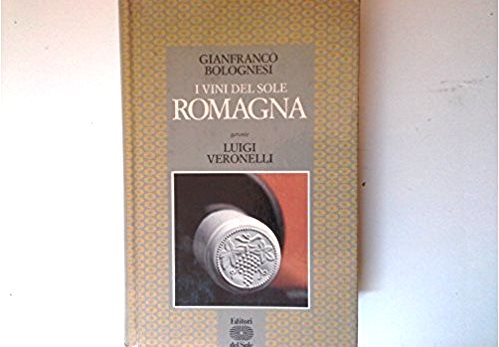
Ma se il percorso finora svolto dalla critica, dagli appassionati e dalle istituzioni ha preso in seria considerazione esclusivamente il sangiovese, negli ultimissimi tempi gli amatori vanno riscoprendo la più antica ed esclusiva uva autoctona romagnola, l’albana. Ed è un bene.
Si sappia che l’albana è femmina solo nel nome, altrimenti è un grosso guerriero con la corazza e la spada, forte, di una forza selvaggia, animale. Un guerriero ribelle e tormentato, irrequieto e umorale, che mette alla prova il talento e la pazienza di chi dovrà affrontarlo.
Nell’attesa di scoprire da dove arrivi e chi siano i suoi antenati, dentro l’albana si intuiscono cromosomi di complicati vitigni rossi e altre curiose bizzarrie rubate qua e là a chenin, vernaccia di San Gimignano, garganega e verdicchio. E forse anche ad altre oscure uve anarchiche coltivate su un’isola che non c’è.

In campagna la varietà, il più delle volte innestata su 420 A, è generosa nella produzione ma sterile nelle prime tre o quattro gemme, nonché irregolare nell’allegagione. Il suo vigore è proverbiale, le sue dimensioni ipertrofiche (l’enorme ossatura dei tralci, la grandezza assurda delle pelosissime foglie, la lunghezza spesso caricaturale dei grappoli) e la sua genetica complessa, tanto da annoverare una ricca collezione di biotipi dalle attitudini differenti: Gentile di Bertinoro e Gaiana (rispettivamente AL7T e AL14T: le uniche esenti da virosi accertate), la Serra biforcuta (AL17T). le “imolesi” Bagarona e Compadrona (AL18T e AL 19T), il rarissimo Pizzigatti e chissà quanti altri individui ad oggi sconosciuti, in quanto la ricerca scientifica sul vitigno è ferma da più di trent’anni.

Se l’albana per l’ampelografia è uva a bacca bianca, il vino che se ne ottiene sprigiona per contro parecchi colori e una personalità irruenta, intollerante ai codici e ai limiti tipologici. Un vino a lento rilascio, impastato di tutte le cose possibili – il sole, la terra, il mare, le radici e le conchiglie, le erbe e i fiori, i frutti e le sue bucce, la ruvidezza e la dolcezza, il sale e l’amaro, l’alcol e l’acidità – che vengono prima trattenute come in una pentola a pressione e poi fatte esplodere senza contegno, in modo talvolta perfino rabbioso.
Chi ama dunque le buone maniere, le mezze tinte, i toni rassicuranti e le traiettorie regolari non potrà mai trovare in questo “bianco non bianco” il suo ideale rifugio: l’albana è una nave in mezzo al mare che deve fare i conti con venti insidiosi e onde alte. Una nave controcorrente da cui è possibile godersi panorami addirittura bellissimi, a patto che alla bellezza si dia un significato affatto ortodosso.
Oggi si cercano bianchi magri, sottili, succosi e facili da bere: in tal senso l’albana è fuori moda. Non che sia un vino gnucco, tutt’altro, ma la fibra del suo tessuto è per natura ruvida, la polpa accalorata, l’acidità sbilenca e mutevole, i profumi autunnali. Certo, esistono numerose variazioni sul tema, più di quante se ne possano immaginare, ma se dal bianco si pretendono innanzitutto aromaticità, freschezza e dinamismo, la relazione non sarà facile.

Alcuni produttori si dimostrano irritati dalla sua libertà e molti bevitori spiazzati dalla sua diversità, ed è comprensibile: l’albana spezza ogni equilibrio possibile su ogni piano possibile, portando il bianco in un contesto stilistico poco esplorato, dove la devianza vale ben più della norma. Del resto se in Romagna negli ultimi quarant’anni il vitigno ha subito un vero e proprio tracollo produttivo e se in altre regioni del mondo non ve n’è traccia, un motivo ci sarà stato e ci sarà. E la ragione sta soprattutto in quel groviglio varietale di cui sopra, nella sua ottusa incapacità di darsi una regolata, in quella proverbiale “ignoranza” contadina e nel suo caratteraccio indomabile che mette alla berlina – il più delle volte è così – chi pretende di domarlo.
Dicevo della bellezza: l’albana che più mi piace è come mamma l’ha concepita. Con qualche difetto incluso, necessario alla causa: l’instabilità cromatica, l’irrequietezza tannica, l’eloquio rauco e l’estrema sensibilità rispetto all’ambiente, all’annata, ai tempi di raccolta e alla sensibilità degli uomini e delle donne che la custodiscono.

Giova credo ricordare a chi non conosca le vicende locali, che oggi si possono bere albana squisite in ogni versione possibile (secche e dolci, senza tacere le variazioni intermedie, oppure le rare versioni metodo classico), dimostrando una versatilità per fortuna non arginabile e un’originalità che i vignaioli più ispirati non vogliono soffocare ma semmai proteggere, assecondare, valorizzare.
E chi sono i più bravi? Tanti, vivaddio. A memoria dico Paolo Babini, Leone Conti, Paolo Francesconi, Cristina Geminiani; e ancora Andrea Balducci e Lucia Ziniti, Claudio Ancarani e Rita Babini, Rita Golinelli e Mauro Mazza, Luciano e Gianni Zeoli, Jacopo Giovannini, Andrea Bragagni, la famiglia Navacchia, Raffaella Bissoni, Giovanna Madonia. E negli ultimi anni Stefano Bariani, Francesco Bordini, Giacomo e Camillo Montanari, Paride Benedetti, Elisa Mazzavillani, Franco Dalmonte e altri che probabilmente dimentico.

L’albana si può produrre in basso e in alto, allevandola a pergoletta romagnola (ideale) e a spalliera (con lunghe potature a Guyot); piantandola su argille tenaci e suoli più fertili, su marne e su arenarie; attraverso raccolte precoci e tardive, con grappoli sani e attaccati dalla botrite; scegliendo vinificazioni in bianco e in rosso, e maturazioni in legno, in acciaio, in cemento e in anfora. Ed è certo che ogni cambiamento modificherà sensibilmente la sua espressione: non solo la morfologia del suo profilo, non solo la qualità, l’intensità e la proiezione dei suoi odori e dei suoi sapori, ma la sua intera connotazione tipologica, trasformandosi e trasfigurandosi, fino a diventare altro da sé.
Stavolta ho l’urgenza dirvi di un’ albana secca prodotta nel comune di Brisighella, uno dei borghi più belli della regione. Brisighella è ai miei occhi la sintesi più credibile della Romagna interna, riassunto dei talenti di un entroterra ancora sconosciuto a tanti, ridente cartolina da spedire a chi pensa che il bello sia sempre di casa altrove. Invece per una volta è qui la Grande Bellezza, nella Romagna lontana da tutto, dall’Adriatico e dalla Via Emilia, dalla pianura e dal mare, in una campagna sconfinata e senza le insidie della modernità.

La pensile Via degli Asini (la strè d’jesan, come dicono quelli del posto), il sontuoso skyline dei tre colli che slancia la Torre dell’Orologio, il Santuario del Monticino e la Rocca Manfrediana, e i carrùggi del budello centrale fanno del borgo medievale di Brisighella anche una meta turistica di tutto rispetto. Ma sono soprattutto i contorni delle sue terre a metterla in luce. Il territorio è così vasto – e così ben curato – che inizia a gennaio e finisce a dicembre: nella bella come nella brutta stagione è un posto salubre, termale, di luminosità meridiane, distribuito in un coacervo di frazioni e parrocchie, e raccolto su due parallele dorsali collinari lungo l’affannato corso del Lamone.
A Brisighella la vite affonda le radici in un dolce esilio sedimentario di calanchi e di arenarie, di marne calcaree e di gessi lunari, a metà tra gli estremi climatici della Pianura Padana (a nord) e dell’Appennino (a sud), in un contesto tuttavia temperato dalla protezione dello spettacolare parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. E che l’alito della terra sia qui particolarmente tiepido lo racconta invero la presenza millenaria (e i risultati qualitativi davvero mirabili) della pianta mediterranea per antonomasia: l’ulivo.
L’orografia del comprensorio è contorta e gli strappi collinari perfino violenti, concedendo tanti punti panoramici e altrettanti, improvvisi canyon senza ritorno, eppure non ho mai incontrato un brisighellese scorbutico e anzi mai meno che cortese: alcuni di loro possiedono oltretutto un vero talento per l’ospitalità, penso a Tarcisio e Nereo Raccagni; a Remo Camurani e Andrea Spada (che brisighellesi lo sono diventati per esigenze professionali). Evidentemente questa geologica armonia degli opposti, questo eterno salotto di venti, uccelli e colorati silenzi costringe le genti del posto a spendersi per la causa, a farsi ambasciatori di una fortuna.

Come il Santiago di Hemingway nella corrente del Golfo, erano più di ottanta giorni ormai che non stappavo una bottiglia di Albana*. E così mi sono riscattato tirando il collo a uno degli ultimi flaconi in commercio del Monterè 2013 che Paolo Babini (Vigne dei Boschi) produce sulle alture appenniniche di Valpiana, estremo lembo meridionale del distretto brisighellese, a 434 metri di quota.
Valpiana, dal latino vallis-plane, che per traslitterazione ci conduce sulla“collina al di fuori della valle”, è in effetti un altopiano laterale al corso del Lamone, un lacerto di marne e arenarie scippato al bosco, con una presenza di argilla più cospicua rispetto alla media dell’Appennino, ideale per le esigenze agronomiche dell’albana. L’argilla le assicura equilibrio idrico e minerale (lasciando maturare con gradualità il frutto), il calcare marnoso ne tiene misurata la vigoria e la porzione arenacea regala al vino una definizione “sottrattiva” altrimenti non ipotizzabile su terreni a prevalenza argillosa.

Se è vero dunque che l’albana è bionda (Monica Coluccia), allora sulle arenarie si fa la permanente, perdendo la sua bizzarra cresta scapigliata. In più, in quei luoghi ormai prossimi a Marradi e alla Toscana, dove le quote altimetriche si alzano e le esposizioni diventano più fredde, l’albana mostra un portamento meno cifotico del solito e scopre senza remore la sua virile acidità: lo sviluppo gustativo lascia così per strada l’atticciata pastosità della pedecollina, portando nel sorso una prestanza più longilinea.
Meglio, va là, non essere fraintesi: l’albana rimane anche nei pressi dell’Appennino un bianco ideale per il bevitore che ha deciso di affidarsi alla sostanza, nella convinzione che la forma possa sempre tradirlo; poiché nemmeno in altura smarrisce l’indole terrosa e quella particolare presenza tannica tipica del vitigno. Qui, molto semplicemente, sospende per un attimo il tiki taka e verticalizza il gioco, sfoggiando una tenacia nordica e alcuni tratti “loirien”, tra Tourenne e Anjou, assai suggestivi ai miei sensi.

Monterè 2013, oggi in un vero e proprio stato di grazia, è tutto questo e altro ancora: a mio parere uno dei più grandi vini bianchi romagnoli di sempre, destinato a evolvere ancora per molti anni a venire.
Da bere magari in un calice ampio, a temperatura da Borgogna, ascoltando la voce di Tom Waits alle prese con splendida Martha (And I was always so impulsive/I guess that I still am) e confidando che la vera Albana rimanga il più a lungo possibile fedele sé stessa: roca e impulsiva.

* Il Vecchio erano ottantaquattro giorni ormai che non prendeva un pesce. L’Albana tuttavia non è vino di mare per il mare, ma di terra per la terra.
Francesco Falcone




