Di tanto in tanto c’è bisogno di dare un significato alle cose. Alle cose più vicine a noi, a quelle che pensiamo di conoscere, che consideriamo scontate. Io l’ho fatto. E dopo vent’anni di servizio mi sono chiesto cosa fosse per me il vino. La risposta sta nelle pagine che seguono: è il mio pezzo più complicato e quello che ho sentito di più. Per scriverlo mi sono impastato di ricordi e di sogni, dal fare l’amore in una vecchia vigna di Boca a quella splendida casa isolata in Val Trebbia, che vorrei comprare per passarci la fine dei giorni.
Rileggendomi, ho capito che al vino devo molto. Gli devo l’uomo che ancora non sono ma che vorrei essere, prima dei titoli di coda. Gli devo l’amore eterno, quello che capita una volta nella vita, se capita. Gli devo lunghe passeggiate in centinaia delle vigne tra le più belle del pianeta, e panorami da vertigine. Gli devo l’incontro con migliaia di produttori, che mi hanno insegnato tutto. Gli devo lo stupore per sprazzi di profumi irripetibili e la speranza di sentirne ancora. Gli devo l’amicizia con persone di valore e la stima di professionisti straordinari. Gli devo la forza dell’indipendenza e allo stesso tempo il benessere dei miei ragazzi. Gli devo il riscatto di una giovinezza inquieta, una via d’uscita dal dolore e il viaggio verso una maturità inaspettata, senza grilli per la testa.

Ora sono pronto a sedermi sulla riva del fiume, portando con me quel Clos d’Ambonnay 1998 che conservo nella mia cantina.
Per realizzare un sogno ostinato e per riempire di sapore l’attesa.
Voglio essere onesto con ciascuno di voi: non ho proprio titolo per parlare di storia. Non possiedo una formazione storica, non sono uno studioso di storia e in verità non sono mai stato uno studioso di qualcosa, nemmeno da ragazzo. Ciononostante, ne scrivo: spiccioli di una storia con cui ho comprato un po’ di felicità. Lo faccio nella convinzione che aver studiato non è sempre sinonimo di conoscenza, e che non averlo fatto non è sempre sinonimo di incompetenza. Chi è d’accordo con questa premessa di carattere generale, potrà credo proseguire la lettura con più serenità d’animo (e con maggiore compassione).

Sono figlio di un gelataio. Mio padre la sera rientrava tardi, quando noi bambini avevamo già cenato. Talvolta capitava che io lo aspettassi da solo, mentre il resto della famiglia era già a letto. Papà trovava distensivo, durante il suo pasto solitario, parlami di lavoro e io imparavo tutto di quel mondo. So da allora, pressoché da sempre, che mi avrebbe voluto nella sua gelateria e sento che non averlo accontentato lo ha ferito. Ma non me ne pento, perché fare l’assaggiatore di vino è un bel mestiere.
Ho assaggiato tanto, per buona parte della mia vita. E senza farmi troppe domande. L’ho fatto e basta. Perché è soprattutto l’assaggio che conta per un assaggiatore. Ho messo in fila i calici facendone un’attività quotidiana.

Bottiglie, bottiglie, bottiglie. Assaggi, assaggi, assaggi. Come l’idraulico i tubi, il professore la lavagna, il pittore il pennello. Come il gatto le fusa, il cane la guardia, il ragno la tela. Abitudine. Normalità. Una normalità che è complicità e confidenza, mai routine oppure ossessione. Col vino ho sempre conservato un rapporto di sano rispetto e di pudica distanza. E col tempo ho imparato ad accettare le sue ambiguità e le mie fragilità, i suoi misteri e miei limiti, tenendomi alla larga da ogni tentazione investigativa.
Nella mia famiglia il vino c’è sempre stato in qualche misura, come nelle famiglie di quasi tutti gli italiani. In campagna si faceva del rosso per il consumo domestico, una sbobba offensiva che farebbe cambiare idea a chi oggi trovasse ruvidi i Nebbiolo o i Sagrantino. Eppure ricordo la mia vergine lingua incatramata con inevitabile nostalgia.
Al mio primo calice di vino comprato con gli amici – avevo sedici anni e non era un calice, ma un goffo duralex da trattoria – mi sentii come in presenza del Graal, invece era solo il Five Roses di Leone de Castris. Che a modo suo rimane una bandiera dell’enologia pugliese (e non solo).

E quando per la prima volta ne bevvi uno davvero buono (a vent’anni: era l’Aglianico del Vulture Don Anselmo 1992 di Paternoster servito in un confortevole Riedel) provai quasi un mancamento, tanto da sentirmi come quelle ragazzine che mettono le scarpe coi tacchi alti della mamma: mi reggevo a stento e barcollavo (a pensarci bene ancora oggi proprio stabile non sono).
Appena qualche anno dopo mi avvicinai ai Ricasoli e ai Mazzei, a Paolo Scavino e a Domenico Clerico, ai Petit verdot pontini e ai Syrah trapanesi; ammirando colori nero melenzana e beandomi di polpute densità; annusando tostature molto alte e parlando di rese particolarmente basse.
Bevevo con fierezza bottiglie concepite in addizione e in orizzontale, figlie naturali delle convessità di Maroni e delle opulenze di Parker. Vini-blockbuster messi a punto dai Ferrini e dai Cotarella in nome di un’esterofilia necessaria e di scelte volutamente apolidi, per cui tutto sapeva di Chardonnay e Cabernet fatti altrove.

La ricerca della ricchezza e dell’esuberanza, dell’estroflessione e della facilità di lettura, arrivò negli anni Novanta a risultati importanti, fruttando al quasi mai ben considerato vino italiano premi e fama a livello mondiale.
Fu quello il periodo della mia formazione, approdo tumultuoso di una nuova strategia enologica cominciata trent’anni prima con la felice esperienza bolgherese di Sassicaia; poi con i rossi sperimentali del Chianti Classico e – nel decennio seguente – con le nuove generazioni dei vignaioli di Langa.
Quei tempi videro da una parte la profonda contrazione dei consumi del vino sfuso, dall’altra l’affermarsi di una concezione vinicola più elitaria e più ambiziosa, indissolubilmente legata alla bottiglia.

Alla base di quel cambiamento epocale furono decisive anche le riflessioni successive allo scandalo del vino al metanolo: nella primavera del 1986 una ventina di persone persero la vita, altrettante diventarono cieche in modo permanente e altri essere umani restarono gravemente intossicati. Per un sorso di vino.
Sul panorama vitivinicolo italiano si accese dunque una luce che parve improvvisa, come se qualcuno avesse girato l’interruttore dopo secoli di buio profondo. Fu una specie di insurrezione contro il provincialismo più paludato e contro la sciatteria delle cattive abitudini. Una riforma delle produzioni massive per mettere fine alla cultura dell’approssimazione (e della morte).
Fu anche una palestra che ci fece un po’ tutti produttori e un po’ tutti degustatori, con l’immenso e ormai maturo Luigi Veronelli nel ruolo di personal trainer di tanti allievi diretti e indiretti, veri e presunti. Burton Anderson era già nel mito, Cernilli e Bonilli all’apice, Gentili, Rizzari, Sabellico e Maroni prossimi alla fama, mentre io leggevo Thomases, Masnaghetti, Arrigoni e Rocco Lettieri, veronelliani senza riserve.

Fino ad allora la letteratura enoica anglosassone coniugava l’Italia solo al passato più remoto: chi ha letto i capolavori di Hugh Johnson, Il Vino Storia Tradizioni Cultura (Franco Muzzio Editore, 1991/2003) e le prime tre edizioni dell’Atlante Mondiale del Vino (Mondadori, 1990/1995/2001), sa bene che è così.
Se il successo internazionale del vino italiano si realizzò appieno è per alcuni semi piantati sul finire degli anni Sessanta e germogliati definitivamente un quarto di secolo fa, con un’accelerazione ulteriore avvenuta all’inizio del nuovo millennio, quando l’immagine del vino italiano scoppiava di salute.
Ricordo quei giorni ambiziosi in cui tutto si consumava in una gara di esibizioni muscolari, sul terreno della tecnica più raffinata e della comunicazione più aggressiva, forzando un confronto planetario e facendo del vino la metafora liquida di una globalizzazione economica, culturale e sociale che proprio allora diventò un importante tema di dibattito nel Paese.
È a quei tempi che si impose lo stereotipo del liquido impeccabile, senza troppe concessioni alla spontaneità, ai sospiri e alle minuzie. Non fu per tutti così e anzi le eccezioni erano numerose, ma quell’esperienza cambiò il nostro modo di fare e di percepire le cose, tanto che a un certo punto <<si afferma una forma di razzismo enologico per cui il vino deve essere pulito, stabile, morbido>> (Corrado Dottori).
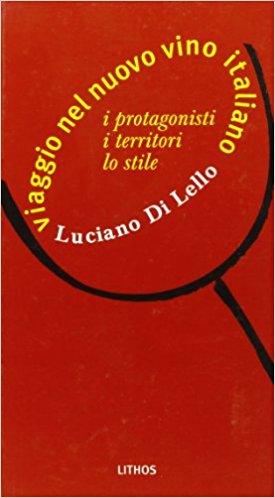
Viaggio nel nuovo vino italiano di Luciano Di Lello (Lithos Editrice, 1997), fu uno dei miei primi libri alcolici letti con trasporto: l’opera si nutriva degli umori di quel clima eccitante, mettendo insieme i protagonisti, i territori e gli stili di una nuova geografia produttiva in Italia. Erano i tempi dei supercloni, dei superwhites e dei supertuscans, termini che enfatizzavano l’opulenza e l’egotismo al di sopra ogni altro aspetto interpretativo.
Nel suo saggio Di Lello elogiava bottiglie già affermate (alcune delle quali ancora ai vertici del vino italiano), affiancandole a una lunga teoria di etichette “nuove” che a distanza di tempo hanno perso terreno tra gli enofili.
Quella che fu la strada della felicità immediata e condivisa, della rassicurante espressione di un vino universale, si è via via consumata in una perdita d’identità di certe referenze simboliche, diventate pressoché indistinguibili le une dalle altre, sebbene fossero originate in luoghi tra loro molto lontani e molto diversi.
E così da qualche stagione molte delle abitudini conformistiche dei ruggenti anni Novanta non trovano più spazio tra i grandi appassionati, non perché sia vane o insignificanti, ma perché caratterizzavano una fase produttiva molto precisa, in cui fu necessario una svolta internazionale.
Oggi viviamo un tempo in cui si esaminano i limiti di quella produzione enologica globalizzata, ipotizzandone la fine, quantomeno nell’ambito dei vini di altissima qualità.
<<È stato l’avvento del cosiddetto mercato globale ad aver propiziato un momento di forte rilancio dei vini artigianali e delle ragioni che li sostengono. Ragioni di radicamento territoriale, di continuità storica e di tutela della tradizione, ovviamente; ma anche ragioni del gusto, di un gusto più esigente e coltivato, più sfumato e più maturo.>> (Giampaolo Gravina)

Anche il criterio valutativo nato negli Stati Uniti con Robert Parker mostra più di qualche crepa ed è meno credibile agli occhi dei bevitori colti. L’insufficiente attenzione alle specificità del vignaiolo, la tendenza a guidare domanda e offerta verso l’omogeneità dei contenuti, l’indifferenza alla complessità delle tradizioni e alle esigenze più intime delle uve sono limiti che hanno spinto molti di noi ad auspicare una critica nuova.
Educarsi al vino in una prospettiva lontana dal mero ossequio a protocolli da eseguire (di cantina o di degustazione, poco importa) è diventata una necessità. I risultati sono già evidenti: si sta passando da una cultura della standardizzazione, che ad esempio i Bordeaux degli ultimi trent’anni hanno espresso in modo esemplare, a una cultura della varietà, il cui emblema è da un lato la Borgogna contemporanea e dall’altro l’arcipelago dei territori dove – per numerose ragioni – si sono conservati vitigni e abitudini locali.
L’insieme di questi cambiamenti sono in qualche misura suggellatti dalla crescita sensibile del cosiddetto vino naturale nel mercato di qualità.
Per ora la dicitura vino naturale resta una consuetudine lessicale priva di riscrontri legislativi e per questa ragione aspramente criticata da chi predilige normare ogni aspetto del mercato (anche il dissenso), oppure fraintesa da chi produce e da chi compra.
<<Il vino naturale è sempre frutto di metodi biologici o biodinamici, certificati oppure no. Non è altrettanto vero il contrario: non è detto che un vino biologico certificato possa in buona fede dirsi naturale, in quanto la normativa vigente, concepita in sede europea, è parecchio permissiva, soprattutto in materia di vinificazione.>> (Samuel Cogliati).
Nella migliore delle ipotesi un vino naturale dovrebbe essere salutare per chi lo consuma (con moderazione): prodotto nel rispetto dell’ambiente, evitando l’utilizzo di fitofarmaci di sintesi e di concimi chimici; vinificato e maturato senza additivi enologici (ad eccezione di modeste dosi di solforosa); concepito nel pieno rispetto delle esigenze di uve, suoli e tradizioni dei luoghi d’origine.
Va detto che molti giornalisti, critici e sommelier affermano di detestare i vini naturali o addirittura di ignorarli, di non interessarsene. Però, a parte una certa civetteria che si può benissimo comprendere (con un portato di motivazioni persino ragionevole), alla fine si sa che in qualche misura tutti ne siamo influenzati. Gran parte dei discorsi sul vino di territorio, sul vino artigiano, sul vino culturale, sul vino autoriale, hanno ormai trovato nel termine naturale in senso lato (con o senza certificazioni di sorta, con o senza l’osservanza di alcuni peculiari protocolli enoviticoli) il proprio centro e orizzonte generale.
Alle teorie di Rudolf Steiner e alle profonde riflessioni di Nicolas Joly, <<il movimento naturalista deve molto anche a Jules Chauvet, che già a metà del secolo scorso rivoluzionò l’approccio alla vinificazione, privilegiando un metodo naturale e ricercando l’espressione più profonda di un terroir. Agli inizi degli anni Ottanta una manciata di viticoltori del Beaujolais lo seguono nelle sue sperimentazioni e con lui formano il nocciolo originario dei viticoltori cosiddetti naturali.>> (Jonathan Nossiter).

Le radici italiche del movimento affondano invece all’inizio del Duemila, durante la mia indimenticabile esperienza nella ciurma porthosiana di Sandro Sangiorgi, la voce critica più autorevole del vino naturale in Italia.
Il punto di partenza di tutto fu probabilmente Fabrizio Niccolaini, fondatore di Massa Vecchia, in Maremma: per conoscerlo un po’ di più suggerisco la lettura di un bellissimo articolo scritto da Giampiero Pulcini e pubblicato sull’Accademia degli Alterati un anno e mezzo fa (all’incirca): Fabrizio Niccolaini, una questione di sostanza.
Fabrizio propiziò in breve tempo l’amicizia tra alcuni vignaioli realmente artigiani, insensibili alle sirene dell’enologia super-performante e più in generale insofferenti alle regole produttive dell’industria. Quella prima cellula naturale mise in rete Angiolino Maule (La Biancara), Nico Bensa (La Castellada), Stanko Radikon e pochi altri, favorendo un periodo prolifico di riflessioni e di condivisioni, di viaggi e di assaggi, arrivando a dialogare con Nicolas Joly, che nel 2001 aveva fondato in Francia la Renaissance des Appellations, esperienza seminale da cui prenderanno forma le numerose forme associative di vinoveristi in Europa. Joly mette al centro dell’universo l’esaltazione dei caratteri peculiari del luogo d’origine, la relazione dei quattro elementi vitali (calore, luce, acqua e terra) e le pratiche dell’agricoltura biodinamica, fino ad allora mai presa in considerazione in viticoltura.

All’inizio del 2003 Sandro Sangiorgi lo invitò a Roma e insieme animarono un lungo seminario sull’argomento, che a quindici anni di distanza va considerato uno degli eventi fondamentali per l’evoluzione del vino naturale in Italia.
Dopo quel laboratorio romano la compagine guidata da Niccolaini entrò nel gruppo francese di Joly, partecipò al Vinexpo e nel 2004 diede vita a Vini Veri (associazione fondata da Bea, Maule, Niccolaini e Radikon) e all’evento annuale di Villa Favorita.
In quei mesi Porthos pubblicò la prima edizione italiana di Le Vin du ciel à la terre di Nicolas Joly (Il Vino tra cielo e terra, a cura di Sangiorgi e Cogliati, 2004) e nel frattempo si registrarono nuovi ingressi di talento nel club dei vinoveristi: Marco Casolanetti (Oasi degli Angeli), Saverio Petrilli (Tenuta Valgiano), Camillo Donati e i carsolini Paolo Vodopivec e Beniamino Zidarich.

Sempre nel 2003 nacque Terra e Libertà/Critical Wine, ultima grande testimonianza dissidente di Veronelli. Un gruppo di amici di varie realtà di movimento raccolse le sollecitazioni di Gino ad occuparsi dei problemi della terra, per fare riflessioni e cercare soluzioni pratiche. Il primo evento si svolse presso il centro sociale La Chimica di Verona, in volontaria concomitanza con il Vinitaly, per dichiarare al mondo dei consumatori la necessità di ricostruire una sensibilità planetaria anche attraverso il vino, il più nobile tra i frutti della terra. Vino di buona qualità, rispettoso dell’ambiente e insofferente alle scorciatoie della produzione industriale.
L’anno successivo Terra e Libertà/CriticalWine diventò un libro grazie alla DeriveApprodi (Prima edizione: maggio 2004): il saggio raccoglieva gli atti dell’iniziativa veronese alimentando un’ulteriore trama di ragionamenti sulla necessità di una produzione onesta e di un consumo consapevole.
Intanto Luca Gargano, importatore e titolare della Velier di Genova, nel 2005 decise di dedicare i proventi guadagnati nel settore degli alcolici nella creazione della prima rete di distribuzione di vini naturali d’Italia, la Triple A (agricoltore, artigiano, artista) i cui meriti sono non solo commerciali, ma anche sociali, culturali e di comunicazione.
Alcune stagioni dopo Reinassance des Appellations si allontanò da Vini Veri per costituire una costola italiana guidata da Stefano Bellotti (Cascina degli Ulivi). E la diaspora continuò con Angiolino Maule che fondò Vinnatur, portando con sé numerosi produttori e creando una spaccatura all’interno del circuito associativo del vino naturale che oggi è sempre più ricco di gruppi, di cantine, di fiere e di seguaci.

Le dimensioni del comparto bio-artigiano sono cresciute al punto da stimolare l’ex porthosiano Giovanni Bietti a raccontarlo con la voce di una collana di quattro libri-guida di buon successo editoriale (Vini Naturali d’Italia. Manuale del bere sano. Edizioni Estemporanee, 2010/2011). Tre anni dopo toccò a Gianpaolo Di Gangi (anche lui per lungo tempo stretto collaboratore di Sandro Sangiorgi) fare il punto della situazione naturalista italiana attraverso la cura de Il Vino Naturale (i numeri, gli intenti e altri racconti, Servabo, 2013), opera corale di Alessandro Franceschini, Simona Centi, Maurizio Paolillo, Giampaolo Gravina, Paolo De Cristoforo, Fabio Pracchia, Nicolatte Bocca, Corrado Dottori e Riccardo Vendrame. E nel 2015 Samuel Cogliati, il più dotato tra gli ex collaboratori di Sangiorgi, diede alle stampe il volume tascabile Vini Naturali (Possibilia Editore), sintetica ricognizione che fa chiarezza sul significato della parola “naturale” nel vino.
Personalmente amo senza compromessi tanti vini di matrice naturale, a patto che siano credibili. Non è il protocollo produttivo a rendere il vino interessante: ma l’uomo e la donna che lo adattano alle proprie esigenze.
Rispetto ai miei inizi, la grande novità del vino sta proprio nelle persone che il vino lo fanno e che lo bevono. Naturalmente mi riferisco alla nostra comunità di innamorati del liquido odoroso, che rappresenta una fetta ristretta di produttori e di consumatori.

I bravi vignaioli vanno comprendendo sempre di più quanto sia necessario mettersi dalla parte dell’ambiente, della storia e della diversità. E i bevitori più curiosi si aprono al vino con l’atteggiamento ideale: più personale ed emozionale, meno schematico e compilativo.
Nei miei laboratori di degustazione si parla poco di intensità e tanto di complessità. Gli assaggiatori che vi partecipano si espongono ad apprezzamenti maturi, fanno libere associazioni, emettono giudizi sganciati dalle logiche del vino grande, grosso e prematissimo.
Il vino buono abita in chi lo beve, non negli slogan di chi lo comunica. Questo emerge nei miei seminari, in cui le persone che incontro investono su se stessi prima ancora che sul loro calice, come da tempo va suggerendo Sandro Sangiorgi nella sua didattica intorno al vino. Si parla di noi, delle nostre sensazioni e si lasciano in un angolo le schede tecniche, i riconoscimenti guidaioli, i punteggi centesimali e il blasone del marchio. La percezione vale più della ricezione.
Stiamo dunque vivendo un cambiamento epocale nell’atteggiamento con il vino. Un cambiamento che non porta solo benefici. Questo è evidente. Ad esempio, la sacrosanta ricerca della naturalità nel vino, della sua spontaneità, della sua onestà, della sua aderenza alle origini, impone qualche avvertenza.

Ai produttori: la diffusione di alcune pratiche ancestrali e la benefica apertura in direzione dell’artigianalità devono dialogare, per essere realmente efficaci, con l’intera struttura cognitiva di un territorio (come ama spesso ripetere il grande Paolo De Marchi di Isole e Olena). Allo stesso tempo non si può prescidente dalla conoscenza della microbiologia, dalle competenze tecniche, dal rigore e dalla disciplina con cui si interviene durante la custodia di un vino. Altrimenti i risultati non potranno che essere mediocri: un conto è la deviazione dal paradigma, ben altro è il difetto grossolano.
Ai consumatori: certe convinzioni secondo cui il vino è autentico solo se disimpegnato e acido rischia di ribaltare i principi del genius loci a favore di una produzione di nuovo omologata e dunque di nuovo insensibile alla complessità reale. L’inciampo linguistico che relega il vino naturale e artigianale a una sorta di beverina macrotipologia (cosa quantomeno bizzarra, perché qualunque tipologia può essere concepita in modo naturale e artigianale) non può che portare fuori strada.
Da degustatore e divulgatore non voglio muovermi su un piano di esclusiva contrapposizione rispetto al modello predominante vent’anni fa, quando bevevo vini ben confezionati e da vitigni internazionali; quando prediligevo i rossi fruttati e colorati, e i bianchi coesi come creme chantilly.

Ecco, oggi non cerco solo vini ottenuti da vitigni locali che siano ridotti o striminziti; salatissimi e citrini; scorbutici e dissonanti; ruvidi e instabili. La freschezza, la vivacità, il carattere sono di partenza dei valori: ma valori relativi, non assoluti. Così come la ricchezza, il calore, l’avvolgenza e la potenza non sono disvalori a prescindere.
Adoro i vini più spontanei e dionisiaci, dalla complessità scapigliata (i vecchi Champagne e i vini ossidativi di più antica tradizione mi fanno proprio impazzire), eppure non rinuncio a valutare caso per caso, ad accettare le differenze.
Un buon Primitivo di Gioia del Colle ha peculiarità quasi opposte rispetto a un buon Primitivo di Manduria: nel primo apprezzo il ritmo, del secondo la densità. Il Verdicchio di Matelica è un altro bianco rispetto al Verdicchio dei Castelli di Jesi: da una parte è decisivo il succo, dall’altra la fibra; uno Chenin Blanc dell’Anjou possiede cupezze che in Touraine smarrisce: scelgo il primo per il temperamento, il secondo per la trasparenza.
E si potrebbe andare avanti incrociando tipologie e territori agli antipodi, perché una Petite Arvine del Vallese, tagliente come lo sguardo di Charlotte Rampling, e un’Albana romagnola, al solito prosperosa come una badessa, nelle mani più educate e nei contesti più appropriati sono entrambe imperdibili, pur nella loro abissale diversità.

Oppure, nel concreto: il Taurasi Riserva 2006 di Perillo, oggi esplosivo come un tramonto africano e lo Chardonnay 2014 di Vignai da Duline, invece coperto come il cielo prima del temporale, valgono entrambi il prezzo della nostra passione: per la loro energia, per il loro sapore, per il coraggio di osare dei loro autori.
Occorre sapersi adattare, sintonizzarsi sulla giusta lunghezza d’onda, imporsi uno sforzo di continua riformulazione, che poi non è uno sforzo ma un piacere. Conviene schierarsi con la propria sensibilità, con la gioia della conoscenza, con la sete della curiosità. C’è bisogno di entusiasmo: ogni recinto può essere reciso con l’entusiamo. Tanto che perfino un Merlot può emozionare: Le Jardin 2010 del Domaine Milan è un capolavoro di provenzale golosità.
Forse si esagera con le premesse, con le indagini. Io stesso lo faccio. E sbaglio. Perché alla fine ti accorgi che i vini buoni si fanno rimanendo fedeli ai suggerimnenti della storia. Senza inventarsi niente. Nei posti del vino più indimenticabili che ho visitato, da Telavi a Barcos, da Funchal a Les Mesnil, da Komen a Pantelleria, da Saumur a Dolceacqua, da Mamoiada a Saarburg, da Valdobbiadene a Beaune, da Serralunga d’Alba a Dürnstein, ho scoperto che vigna e vino sono per quelli del luogo una cosa di famiglia: niente di più e niente di meno; si parla di rispetto più che di progresso. E io mi sento un po’ come loro, un custode dell’assaggio.
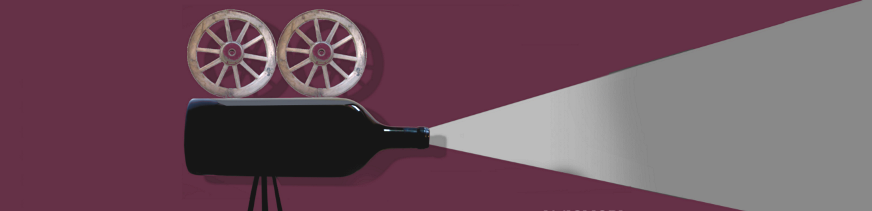
Assaggiando, cantina dopo cantina, ho compreso come il vino più sincero sia un bracco implacabile che fiuta il terreno e ce lo srotola come la pellicola di un film. Se è vero, allora il ruolo del bravo vignaiolo è quello del cineasta dotato, che deve guidare la creazione senza soffocare la libertà delle risorse a disposizione; che deve sorvegliare i processi produttivi trovando l’equilibrio nel quale il controllo diventa pensiero e mai norma; che in ultima analisi deve permettere al vino di trovare una strada credibile, di respirare e di vivere.
Ha ragione Nicola Perullo quando dice che un vino non sa di terroir. Però durante il mio ultimo viaggio all’estero, in quella Georgia dove probabilmente il vino nacque, qualche migliaio di anni fa, ho sentito una tale simbiosi tra uomo, vino e territorio; un tale senso del tempo (un tempo biblico per certi versi); una tale devozione per ciò che del passato sta nel futuro (e viceversa), che l’impasto sapeva di un’unico sapore. Indimenticabile.
Indimenticabile come lo scorso 21 maggio a Modena, quando a mezzogiorno lei si accomoda in sala per partecipare a una mia degustazione pubblica, a tre anni dall’ultima volta. È bella come se il tempo si fosse fermato, io emozionato come un bambino.
Ecco, quel giorno ho accettato che il vino diventa altro quando lo porti vicino al cuore. Molto altro. E io non so fare altrimenti.
A Carlo Macchi, per l’opportunità e l’amicizia.
Ai miei ragazzi, per la vita.






 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 