E’ con malcelato onore che ospitiamo uno piccolo trattato sul vin santo di Giuseppe (Beppe) Lo Russo, sicuramente uno dei più importanti studiosi della storia della gastronomia (italiana e non solo), giornalista e, last but not least, caro amico del nostro direttore. Grazie Beppe!
La cucina come l’enologia toscana è dominata, diremmo stretta, fra due miti di fondazione ugualmente prepotenti, quello della cucina alta di corte, signorile, che ha come riferimento tradizionale le due cugine Caterina e Maria de’ Medici, e l’altro della cucina povera della grande civiltà contadina, con tutta la retorica sulle radici, cucine della memoria, cucina cucinata, ingegno nato dalla necessità e via dicendo, e che oggi si tende a rendere astrattamente con locuzioni abusate del tipo: radicamento, espressione del territorio ecc.
Anche il vin santo non si sottrae a questo doppio universo di riferimento, vere e proprie proiezioni mitologiche dell’immaginario gastronomico. Esso partecipa di una duplice natura, nobile e contadina insieme, vino di corte prima, da salotto borghese poi, e vino finalmente da casa di campagna, espressione dell’ospitalità e della festa contadina.
Non c’è dubbio che i vini dolci, oggi diremmo con residuo zuccherino, nascano come vini da signori, contrapposti a quelli garbi, come nei testi cinque-seicenteschi erano detti i vini asciutti. Il loro consumo non era generalizzato – non erano vini da pasto, d’ogni giorno – tuttavia restava pur sempre un lusso legato a una pratica enologica che solo le classi abbienti potevano permettersi.
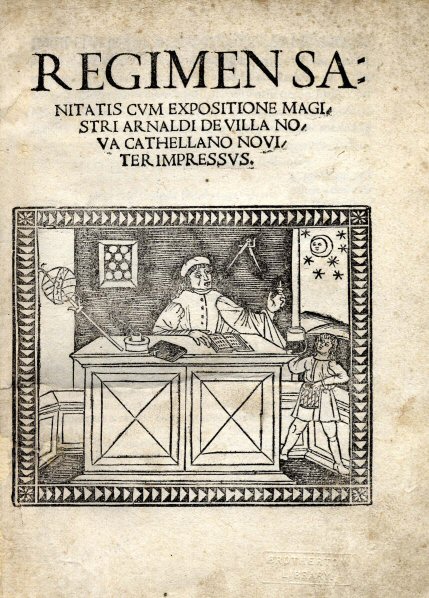
È nota la predilezione in epoca medioevale per i vini fermentati dolci, bianchi e profumati, che già intorno all’anno 1000, nel Regimen sanitatis della scuola medica di Salerno, venivano raccomandati come migliori. Una predilezione che fece la fortuna del moscato o moscatello, unitamente all’autentica passione per il vin greco di Candia e Cipro, che Genova e Venezia con i loro traffici assicuravano alle mense aristocratiche.
Lasciando da parte suggestioni di nascite millenarie (etrusche!) e questioni etimologiche fantasiose o comunque non suffragate da prove documentali, proviamo ad attenerci ai testi.
La prima attestazione del nome vin santo è del 1773 nella Oenologia di Cosimo Villifranchi, mentre, scorrendo l’elenco lasciatoci da Giovan Battista Scarlino nel suo Nuovo trattato della varietà e qualità dei vini che vengono a Roma (1554), il vin santo non compare, come non compare nella Lettera sulla qualità dei vini (1559) del bottigliere di papa Paolo III Farnese, Sante Lancerio. E ancora, il suo nome non figura nell’opera del naturalista e medico aquilano Andrea Bacci (De naturali vinorum historia, 1696), né nel trattato di Bernardo Davanzati sulla Coltivazione in Toscana (1600). Francesco Redi non lo cita nel suo celebre ditirambo Bacco in Toscana (1685), né figura nel meno noto Bacco in Casentino (1741) di un suo tardo imitatore.
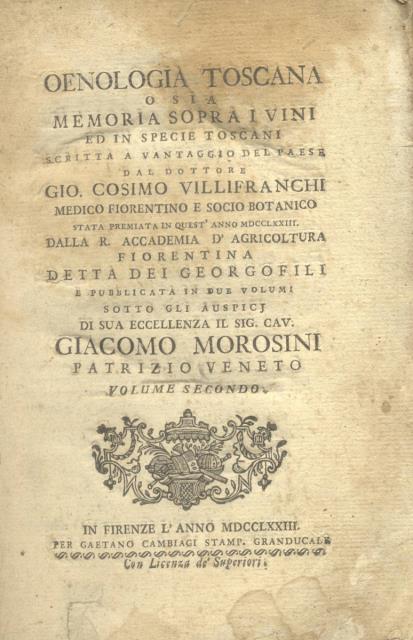
Bisogna arrivare al 1774, con Ferdinando Paoletti, pievano di Villamagna, che ne L’arte di fare il vino perfetto e durevole, parla di vini santi i quali, scrive, richiamano, a seconda del tipo di lavorazione, quello di Malaga o quelli di Cipro.
Più tardi, nel 1804, Matteo Biffi Tolomei, nel Saggio di agricoltura pratica toscana e specialmente del contado fiorentino, li definisce “vini dolci come quelli di Grecia”.
La descrizione del procedimento, che è poi quello classico per ottenere il vin santo, la troviamo però solo nel 1762, nelle regole redatte da monsignor Francesco Cappelli, dove si parla per la prima volta della preparazione di “vino alla greca” o “aggrecato”.
Infine, nell’edizione italiana del 1836 Della maniera di fare il vino, uscito in francese nell’Enciclopedia di Agricoltura Pratica, troviamo un’interessante giunta, riguardante la “Maniera per fare gli sciroppi d’uva e i vini di Lipari, di Trani, Bitonto, moscato di Siracusa, Marsala, Vin Santo, Aleatico e Moscatello di Toscana, Nebbiolo, Chiaretto, Sciampagna ecc.”.
Un’inchiesta sulla Toscana agricola del 1881 ci testimonia l’uso fra i piccoli proprietari e fra i contadini di preparare un piccolo caratello di vin santo per uso della famiglia e degli amici; si dice per lusso o per capriccio.
Con l’Ottocento si compie dunque l’imborghesimento e la ruralizzazione, per così dire, della preparazione e del consumo del vin santo. E l’Artusi, che consacrerà le padrone di casa a vestali della cucina borghese, non mancherà di citarlo nel suo celebre manuale come ingrediente della schiacciata livornese, della mostarda fiorentina e come vino da dessert.

Ora, sulla base di queste notizie c’è da credere che il vin santo, nato da una pratica enologica tecnologicamente avanzata e signorile a imitazione dei vini greci, e scaduta poi nell’uso popolare, sia diventato e si sia conservato come un patrimonio della cultura contadina.
In altre parole, se le sue origini, relativamente alla tecnica di produzione, sono antiche e di ascendenza alta, la sua evoluzione, fino alle soglie del Novecento, è nel segno di una sua progressiva diffusione popolare, come emulazione di una pratica di vinificazione un tempo esclusivamente signorile.
Questa diffusione popolare spiega perché il vin santo sia raramente citato come tale nella letteratura enoica novecentesca: esso non identifica un vino riconducibile a una sola area geografica determinata, ma un’intera tipologia di vini accomunati da una tecnica di preparazione pressoché simile. Non si può pensare dicendo vin santo di identificare un vino, come chi dica invece Aleatico dell’Elba, Malvasia delle Lipari o Moscadello di Montalcino. Del resto, ancora oggi la sua diffusione è rimasta generalizzata, e il vin santo non è soltanto – anche se per la maggior parte – toscano, ma anche trentino, piacentino, umbro, marchigiano.
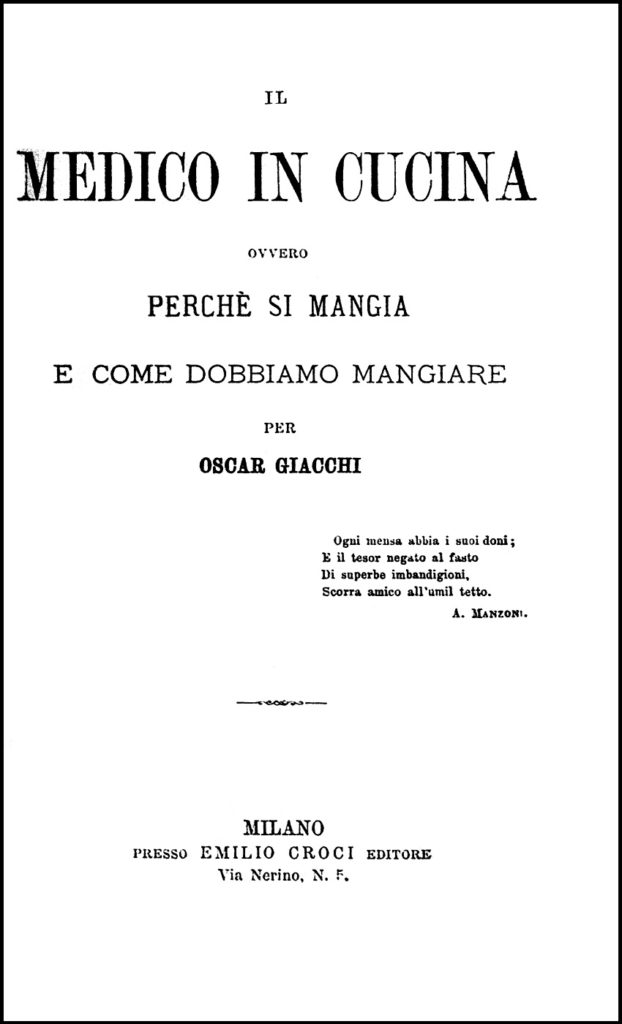
A conferma della genericità della denominazione, nei principali periodici di gastronomia e cucina, “Il Messaggero della Cucina” (1903-1943), “La Cucina Moderna” (1905-1910…) e “La Rivista Italiana d’Arte Culinaria” (1905-1913), non ho memoria di aver mai trovato alcun cenno al vin santo; né il suo nome ricorre nei tanti menù riportati, ufficiali, di lusso o casalinghi.
Va anche detto che sul vin santo per lungo tempo ha pesato una prescrizione di tipo dietetico se non terapeutico.
Ancora nel 1881, ad esempio, nel Medico in cucina del dottor Oscar Giacchi, originario di Monsummano e finito a dirigere il Manicomio criminale di Racconigi, si parla di moscadello, aleatico e vin santo dei quali si dice:
Questi liquori riescono in modeste proporzioni quali tonici eccellenti…[e confortano] le pareti dello stomaco molto meglio della china, del legno quassio…e di tant’altre porcherie che gli speziali assicurano rendere la robustezza a questo rispettabile matraccio che distilla tutti i giorni i succhi per il laboratorio della vita.
A conferma di quanto fosse comune questa opinione, ancora nei primi del Novecento (1901-1909), nelle corrispondenze da Firenze del cuoco svizzero francese Louis Monod, il vin santo è semplicemente indicato come “un vino bianco dolce, molto richiesto”, consigliato dai medici come tonico e ricostituente nei casi di astenia e debilitamento.
Tuttavia, senza presumere d’essere esaustivi, scorrendo la letteratura enoica successiva, la connotazione alta del nostro vino non sembra del tutto persa.
I “vini forzati e santi”, secondo la classificazione riportata da Arturo Marescalchi nel suo libretto La degustazione e l’apprezzamento dei vini (1920), rientrano nella categoria “vini di lusso”, dei quali non si può né si deve usare pasteggiando. E questa nota, ribadendo l’antica modalità del suo consumo, rende comunque testimonianza della sua origine signorile.

Umberto Notari, fondatore nel 1929, e direttore fino al 1934 de “La Cucina Italiana”, nel suo libro L’arte di bere (1933), nel prefigurare le moderne vinerie che valorizzino i “settantacinque vini imperiali d’Italia”, stila una lista in cui, fra i vini dolci, il vin santo non figura, mentre ci sono il moscato di Canelli, quello dell’Elba, di Trani, la malvasia delle Lipari, il moscato di Siracusa, la malvasia di Bosa e il moscato di Cagliari.
Tuttavia un processo d’individuazione del vino si era già avviato.
Nel Ventre dei popoli (1905) dell’erudito di cucina e gastronomia Alberto Cougnet si cita in Toscana il “vino santo” di Siena e quello di Montalbuccio, delle colline senesi, e di Sant’Ellero. Ma è nel 1931 – il rilevamento però è del 1929 – che abbiamo una prima, migliore differenziazione nell’universo del vin santo e di quello toscano in particolare.
Nella Guida gastronomica del Touring, dopo aver elencato fra i vin santi quello di Gambellara in Veneto e i passiti e vinsanti della Venezia tridentina (Castel Toblino, Arco, Delle Sarche, di Cavedine, di Vezzano, di Trento, Drò, Padergnone) ed elogiato soprattutto quelli prodotti in Umbria (di Monterubiaglio, fra i territori di Orvieto e Castel Viscardo), per la Toscana si legge:

In tutta la Toscana si producono PASSITI E VINSANTI, più o meno liquorosi, di vario tenore alcoolico, ed in alcuni luoghi delle MALVASIA: sono pregiati il vinsanto, il passito e la malvasia del Chianti, il vinsanto di Pescia, più alcoolico e meno dolce del passito; la malvasia ed il vinsanto di Montegonzi, in quel di Montevarchi(diciamo fra Montevarchi e Radda in Chianti); il vin santo delle colline pisane e pistoiesi; il vinsanto di Pereta, nel Grossetano, assai alcoolico; il vinsanto di Montebello, a Certaldo, ove si produce anche una Verdea dolce e profumata; il vinsanto di S. Giminiano, asciutto e generoso, che si conserva “stravecchio” in bottiglia.
Si passa poi a citare (in maiuscolo) il MOSCATO di Montalcino, il VERMENTINO, bianco dorato, dolce, di oltre 12° d’alcool, prodotto nelle colline di Candia, tra i comuni di Massa e Carrara, analogo al Vermentino ligure; uno spumante dolce fatto a Casatico nel Lucchese.
L’Elba continua a occupare un posto di tutto rilievo per la produzione di vini dolci con l’aleatico, il moscato e gli spumanti.
Solo di recente, dalla signorile pratica enologica da cui aveva avuto origine, e che si era generalizzata nell’uso contadino grazie al miglioramento delle pratiche in vigna e cantina, il vin santo ha ripreso una sua identità precisa, quella che lo vede riposizionato (per usare un termine del marketing) nella prestigiosa categoria dei vini da meditazione. Fatto che viene da considerare come un ritorno alle sue nobili origini.
Tuttavia, in Toscana, se escludiamo le sottozone del Chianti, i vin santo a Doc sono un buon numero. In Italia restano solo altre sei denominazioni non toscane: il Vin santo dei Colli del Trasimeno, dei Colli piacentini, di Vigoleno, di Gambellara e di Gambellara Classico e il Vin santo trentino.
Questa situazione, con numerose aziende produttrici, rende paradossalmente difficile una caratterizzazione del prodotto che, seppure trova una sua forte indentificazione con un unico territorio regionale, più spesso la trova nel nome delle singole aziende produttrici.
Alla luce di queste considerazioni, la questione che oggi si pone è come operare per promuovere il “prodotto vin santo”, esaltando le differenze fra le diverse aree di produzione e fra i diversi produttori.




