La degustazione è immaginazione.
Sfoggio di figure retoriche.
Idee che si associano, libere di volare.
La degustazione è esperienza.
Studio che reclama libertà.
Consapevolezza che si deposita via via, come grasso sui fianchi, rughe sul viso.
La degustazione è umanità, umiltà, humus.
Luce tra le fragilità.
Accettando il “sacro poco che siamo” (PPP).
La degustazione è creatività.
Abitare i confini geografici della scienza.
Rinunciare alle rigide logiche razionali.
La degustazione è silenzio.
Parole che sbocciano come fiori, nel limbo della riflessione.
Di silenzi e voci che tra loro dialogano, come la vite dialoga con la terra e il cielo.
La degustazione è cercare.
La pila dei sensi accesa, in mezzo a rovi di ipotesi.
Fino a perdersi, pungersi, ferirsi nel vino.
La degustazione è illusione.
Appunti aleatori come rugiada.
Istantanea che vive e muore, metafora di vita.
La degustazione è tempo.
Continua attesa.
Pazienza durante il viaggio senza meta.

Quello della degustazione è diventato un mondo aperto e assai più popolato di un tempo. Negli ultimi vent’anni un grosso numero di persone che prima non vi aveva sostanziale accesso, è entrato nel club. Non che prima gli italiani non lo bevessero il vino, anzi ne bevevano parecchio, ma appunto lo bevevano e basta. Non avevano né tempo né occasioni né stimoli per interessarsi a un’attività apparentemente futile come quella di degustare, un passatempo che allora interessava a pochi: il più delle volte si trattava di addetti ai lavori, di artisti, di aristocratici, di solidi professionisti.
Il big bang della degustazione è dunque un evento tellurico piuttosto recente. Tanto recente quanto repentino e appunto, tellurico. Per “big bang della degustazione” intendo dire che vi fu un attimo in cui improvvisamente investire tempo, studio, viaggi e riflessioni intorno a una bottiglia di vino divenne se non necessario per tutti, quantomeno prezioso per tanti. Da lì in poi, si sono come spalancati enormi cancelli che ogni giorno lasciano affluire comodamente un pubblico sempre più eterogeneo. Un pubblico che può informarsi diffusamente e spesso gratuitamente (uno stimolo decisivo per capire, interpretare, comprare e viaggiare) e può acquistare vino in un numero pressoché illimitato di enoteche online (che permettono l’acquisto di ogni bottiglia possibile, in ogni momento possibile, da ogni angolo del pianeta possibile).

Così, eccoci qua: il mondo della degustazione non ha più caste, élite, guru, ma un esercito di uomini e donne in continua formazione, pronti a stappare, fotografare, testare, criticare, raccontare e influire. Si tratta di una rivoluzione, non c’è dubbio. Una rivoluzione che ha rotto ogni privilegio possibile, lasciando campo libero a chiunque sia attratto dalla conoscenza intorno al vino (e al cibo). Fino a vent’anni fa quelli che facevano della degustazione un hobby appartenevano a una piccola comunità circoscritta, i cui confini – salvo poche eccezioni – erano determinati dalla fortuna di frequentare ristoranti ed enoteche di alto profilo: insomma incontrare un degustatore (quindi un bevitore colto, informato e in grado di ben argomentare sulle cose del vino) era piuttosto raro.
In quella comunità piuttosto ristretta si parlava una sola lingua in codice, il “vinese”, meno comprensibile dell’aramaico e più indigesta del greco antico. Una lingua scabra, burocratica, conservativa, di poche parole. E siccome adoperare poche parole significa avere pochi pensieri (<<noi non solo pensiamo in una lingua ma la lingua pensa con noi o, per essere ancora più espliciti, per noi>> scrive Gustavo Zagrebelsky) non dovrà suonare eccessivamente astiosa la considerazione che quel piccolo mondo lì, parecchio autoreferenziale, a un certo punto abbia finito per rinchiudere il vino in un rito sacrale e pressoché inaccessibile ai neofiti, con una serie di regole rigide e omologanti.

Al contrario, la democratizzazione della degustazione per tutta l’umanità possibile, ha avuto come esito più tangibile l’ampliamento del linguaggio e – per stretta conseguenza – delle idee. Idee che transitano e si depositano ovunque, tra chi il vino lo produce, lo vende, lo comunica, ne scrive. E così oggi la nuova umanità italiana del vino mette la degustazione in cima alla lista dei suoi desideri e contestualmente sta imparando a “parlarla” e a “pensarla” meglio. A pensare in modo più naturale, più spontaneo, più comprensibile; a parlare del vino come si parla con il cibo come si parla con l’arte come si parla con la poesia come si parla con il sesso come si parla con la vita. Animando la degustazione senza tabù, con un lessico aperto e con una ricca collezione di nuove sequenze emotive, scandite da una ben più ampia geografia di comparazioni e di confronti. Sono pertanto saltati i ghetti, le gabbie, gli steccati, i confini, i fossi, i fili spinati e tutto che sapeva di elitistica autoreferenzialità. E così oggi tante donne e tanti uomini hanno a cuore la degustazione, che stimola l’incontro con il vino, con i suoi luoghi e con la sua gente, in un circolare movimento dialogico nel quale si ascolta e si parla, si riceve e si dà.

Ciò che oggi sta molto a cuore a tanti appassionati è approfondire il significato della degustazione. Cosa significa degustare un vino? Ecco, grossomodo significa conoscerlo. Conoscerlo attraverso un percorso che porterà l’assaggiatore a guardare, annusare e gustare un po’ di liquido in un calice. In seconda battuta, degustare significa pensarlo quel vino, parlarne, metterlo in contatto con altri vini, riflettere sulle sue qualità e sul suo pedigree.
Così, tra il degustatore e il vino inizia una vera e propria relazione. E come tutte le relazioni, a distanza di tempo, potrebbe rilevarsi ripetitiva, faticosa, noiosa. Vuoi per pigrizia, vuoi per consuetudine, ma ancora più spesso per paura che cambiare qualcosa possa metterci in difficoltà. Ai tanti degustatori che si proteggono nelle loro rassicuranti convinzioni, per cui un rosso è un rosso, un bianco è un bianco, uno spumante è uno spumante; per cui un rosso è tannico, un bianco acido, uno spumante gasato; per cui un rosso va servito caldo, un bianco freddo, uno spumante gelido. Ecco, a quei degustatori lì, alcuni di loro anche molto dotati; a quei degustatori che preferiscono seguire il percorso di sempre, che usano come uno scudo per difendersi da ogni eventuale deviazione, da ogni possibile tentazione; ecco, io a quei degustatori suggerirei di fare un passo avanti, prima di entrare nel tunnel di quella relazione ripetitiva, faticosa, noiosa.

Oggi è più facile rispetto al passato: sono anni di cambiamenti, di riflessioni e di considerazioni intorno alla degustazione. Anni in cui stiamo imparando che “solo chi non esclude nulla, neanche la cosa più enigmatica, vivrà la relazione con un altro come qualcosa di vivente e attingerà sino in fondo la sua propria esistenza.” Rainer Maria Rilke non parlava di vino, ma l’essenza di quel pensiero così ispirato intercetta ogni possibile cosa possa riguardarci.
Dovendo fare una lista delle priorità, la passione è un sentimento indispensabile per rompere ogni possibile routine: passione ed entusiasmo ti catapultano nel vino – come nella vita – con un’energia altrimenti impossibile da sentire. Vivere nella passione, sentirsi appieno trasportati da ciò che facciamo, è un antidoto alla monotonia e un buon punto di partenza per essere degustatori che sanno relazionarsi con il vino. Non c’è dialogo aperto e autentico, tra un degustatore e il vino, se non quando la ragione più razionale e scolastica, formata nella pedissequa ripetizione delle pur valide nozioni accademiche, si converte in passione. La sola visione tecnica, del vino e della degustazione, non riesce ad aprire le finestre nascoste verso un percorso di indagine, di comprensione, di crescita, di maturità intorno al vino (al vino nel calice e al vino fuori dal calice). Per aprire quelle finestre occorrono disponibilità, curiosità, sensibilità, immaginazione. Un degustatore deve educarsi all’incontro, adattarsi al percorso, accettare le differenze e auspicare la novità, lasciandosi trascinare dal torrente delle metamorfosi, che nel vino sono consuete.

Crediamo sia appagante entrare in relazione col vino come si fa tra esseri umani e come sarebbe opportuno fare tra esseri viventi (il vino vero è vivo), uscendo da sé stessi e dalle proprie convinzioni, per immedesimarsi in ciò che è altro da noi. Non può esserci una relazione prolifica, tra noi e il vino, senza un pieno coinvolgimento. Se vogliamo degustare il vino godendone appieno, laddove la parola “godere” serve qui a sottolineare l’intensità e la profondità del piacere; se vogliamo creare una relazione prolifica tra noi e quel vino, tra noi e chi quel vino ha prodotto, tra noi e l’ambiente che quel vino ha nutrito, tra noi e il tempo che quel vino ha trascorso nel suo flacone, tra noi e le motivazioni che ci hanno portato a sceglierlo in mezzo a milioni di altri vini, allora è necessario provare trasporto. È necessario farci accompagnare dalle emozioni. È vero, il vino non parla, ma non occorre essere folli e visionari per comprendere che è possibile comunicare, dialogare, vivere, amare con il silenzio e nel silenzio, perché anche il silenzio sa tenere banco, basta saperlo ascoltare e poi saperlo animare, regalandogli suono e respiro attraverso la nostra disponibilità creativa.
La degustazione ruota attorno a due sole norme necessarie: la prima è l’amore intenso per il sapere, la passione compulsiva e irrefrenabile per la conoscenza in tutte le sue forme. La seconda è il valore dell’indipendenza dai poteri forti.
La degustazione non trova ispirazione nella linearità del pensiero, ma nell’allusione, nell’evocazione, talora nell’illusione.
La degustazione alterna sapere e distacco: sapere per conoscere con sapore, distacco per conoscere con lucidità. E funziona al contrario, come un continuo paradosso, poiché al vino non occorre prendere le misure, semmai dal vino bisogna prendere le distanze, se si ha l’ambizione di comprenderne il meccanismo.

La degustazione è ciò che emerge in superficie, ma è soprattutto ciò che palpita in profondità (e ciò che si intuisce in prospettiva).
La degustazione delimita i confini per valicarli, determina i territori per attraversarli: la degustazione è un ponte perenne sostenuto dai pilastri della conoscenza e dell’immaginazione.
La degustazione non fissa, non circoscrive, non specifica; la degustazione è apertura, condivisione, contaminazione; la degustazione è mescolanza con tutto il resto possibile.
La degustazione è inutile per l’umanità intera, ad eccezione di una striminzita fetta di sognatori per cui è invece vitale: i degustatori vivono in una tribù e sono minoranza etnica.
La degustazione intercetta le eccezioni e le molteplicità, e rifugge dalla ricerca di un modello unico, assecondando il carattere variabile del vino, come di nuvole e vento.

La degustazione non potrà mai essere una disciplina, e se lo è, allora è disciplina indisciplinata, poiché è nella disobbedienza delle consuetudini umane che si basa la sua esistenza. Affermare il contrario, collegare cioè la degustazione a una questione di certezze definite e definitive, significherebbe scambiarla per un metodo noiosamente scolastico.
La degustazione è invece ciò che di più distante vi è dalla scuola; la degustazione è un’infinita vacanza intorno a una vigna e a un calice; l’eterno tentativo di stare accanto a un piccola porzione di pianeta, per scoprire che in quel pezzo di terra, a saperlo annusare, c’è il mondo intero.
La degustazione è aprirsi a un mondo che è fatto di altri mondi; aprirsi a un mondo che è fatto di vite, vite in senso botanico e in senso umano. Degustare è sapere del sole e della pioggia, delle radici e delle foglie, dell’acidità e dei tannini, dei compattamenti e dei diradamenti, delle latitudini e delle altitudini, dei portainnesti e dei cloni. E ancora, di storia e di aneddoti, di mercato e di moda, di giurisprudenza e di prudenza, di fisica e di metafisica, di materia e di spirito; di sesso e di amore; di colori e di sguardi.

La degustazione è accogliere tutto con entusiasmo per la scoperta, poiché non si può separare il vino dal cosmo che lo ha concepito, conosciuto, amato, detestato, archiviato. Degustare è accettare il relativismo sensoriale: non esiste il vino assoluto né l’archetipo del vino perfetto. Degustare è fare i conti con una complessa mescolanza di cose, nella convinzione che degustare è sinonimo di vita.
La degustazione è fare i conti con l’instabilità del vino, con la sua naturale predisposizione a modificarsi giorno dopo giorno; per sintonizzarsi con gli sconfinati orizzonti di un tempo difficile da determinare. Accettando il nostro temperamento, le nostre certezze e le nostre insicurezze, le cose che sappiamo e le cose che ignoriamo, le quali ci fanno cambiare il modo con cui valutiamo il vino.
Nella vita di un degustatore c’è anche il tempo della valutazione. Il vino non va solo bevuto e goduto, va anche valutato. E alla valutazione finale, più o meno credibile a seconda dell’applicazione e del valore di chi degusta, si può arrivare in due modi: con un protocollo sensoriale ortodosso (degustazione tecnica), che suggerisce una prassi e un linguaggio tecnici condivisi dagli addetti ai lavori, oppure con un approccio meno scolastico e un’interpretazione per così dire più creativa (degustazione immaginativa). Tra i due metodi corrono differenze sensibili: il primo conduce a un approdo schematico, prevedibile e spesso autoreferenziale (benché efficace per alcuni); il secondo si affida alla personalità del degustatore, che valuterà il vino con un di più di trasporto personale.

La degustazione immaginativa non si occupa di un vino in modo diretto, ma gli si pone accanto; non arriva dritta al bersaglio grosso, ma tocca alcuni punti ad esso vicini. La degustazione immaginativa racconta il vino in modo obliquo, indiretto; gli gira intorno, valorizzando le sue potenzialità evocative. La degustazione immaginativa concede – a chi ascolta – lo spazio per arrivare alla comprensione del liquido, lasciando all’interlocutore il tempo e il passo dell’analisi finale. La degustazione immaginativa non è il fine (passivo) di un’attività, ma il risultato (attivo) di una conquista personale. La degustazione immaginativa è tanto più individuale nell’approccio quanto più universale e pedagogica nel risultato finale, perché stimola l’iniziativa, l’autonomia e l’indipendenza del degustatore (e di chi lo ascolta). La degustazione immaginativa è un utile strumento narrativo, perché apre all’altro e lascia a chiunque lo spazio per entrare in un mondo altrimenti selettivo. La degustazione immaginativa non mette confini, ma allude a qualcosa che va oltre la disciplina, arrivando al cuore di chi ascolta. La degustazione immaginativa è creativa, si addice al dialogo, alla discussione, alla riflessione e perfino alla poesia, che per definizione è atto creativo (la parola greca poién, da cui poesia, vuole dire creare).
Ben altra cosa è la degustazione tecnica, che stabilisce un contorno rigido, fissando un limite oltre il quale non è lecito andare. La degustazione tecnica è una diagnosi, una sentenza; richiama l’esattezza, la definizione; si addice al linguaggio burocratico e scientifico, e lascia poco spazio per altro da dire. La degustazione tecnica non suggerisce un dialogo, imponendo un monologo mascherato. Mentre la degustazione immaginativa apre al non detto o all’indicibile, la degustazione tecnica non tollera pensieri inattesi. Se la degustazione immaginativa permette al degustatore e a chi lo ascolta di intendere più profondamente un vino (secondo la propria libertà interpretativa), la degustazione tecnica si sostituisce alla comprensione attiva dell’altro.

Laddove la degustazione immaginativa include e genera riflessioni, la degustazione tecnica esclude e riduce spesso la pratica dell’assaggio a un modulo da compilare. La degustazione immaginativa permette al degustatore di volare oltre il suo ruolo più stringente, mentre la degustazione tecnica impone un ordine, costringe e imprigiona in uno schema. Alla degustazione immaginativa corrisponde la filosofia del viaggio quando la meta non è prestabilita, il vagare nomade, la raccolta frugale, il tempo gratuito della festa, l’architettura creativa, lo sguardo rivolto al cielo per lasciarsi rapire da una nuvola. Alla degustazione tecnica invece si addice la vita ben programmata, il fastidio per l’incertezza o la sorpresa, la giornata scandita dall’orologio, il tempo che è denaro, il sesso ordinario, il pranzo a mezzogiorno, la cena alle sette, la routine senza via di fuga. La degustazione tecnica alza ponti levatoi intorno ai concetti e alle idee; perché induce a popolare di muri e di numeri la nostra mente di assaggiatori. La degustazione immaginativa implica invece un atto plurale e libero, si apre alla complicità e alla conversazione, a un versare insieme, e insieme bere, vivere, sognare.
Io scelgo la degustazione immaginativa perché è più in sintonia con l’indole imprevedibile del vino; perché è più libera, come libera è la bellezza; perché può facilmente trasformarsi in qualcosa di molto prossimo alla narrativa. Non è sempre così, ma leggendo le pagine di Paolo Monelli, di Mario Soldati e di Armando Castagno, per citare tre grandi scrittori di epoche diverse, la letteratura è davvero a portata di mano. Il vino ci educa a migrare, a metterci continuamente in viaggio, a intercettare piccoli dettagli che sono patrimonio esclusivo di quell’emisfero, di quel continente, di quello stato, di quella regione, di quella provincia, di quel comune, di quella frazione, di quella località, di quella tenuta, di quell’appezzamento, di quella parcella. Chi abbia solo tentato di avvicinarsi alle vicende enologiche della Borgogna ne sa qualcosa. Chi abbia mai frequentato Paesi come la Georgia e la Moldavia ne sa qualcosa: per degustare un arcaico Rkatsiteli georgiano e meraviglioso Pinot Noir di Vosne-Romanée non basta una scabra scheda tecnica di degustazione da compilare come si fa con le registrazioni su internet. No, non basta, poiché occorre scardinare tutta l’immaginazione che è in noi, per godere appieno di quei vini.
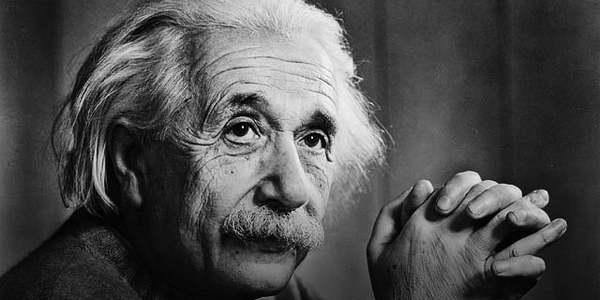
Per godere e soprattutto per imparare. Ciò che più mi piace del mio mestiere è la pressoché infinita possibilità di imparare. La rara opportunità che il vino e la degustazione mi regalano di scoprire cose nuove, ogni volta. Non importa se sono cose buone, ottime, eccellenti o di rustica fattura. Anzi, a dire il vero tante volte è nella modestia delle premesse che ho trovato esiti sorprendenti. Non importa se quei vini sono in sintonia con le mie preferenze oppure no. Anzi, a dire il vero più i vini mi sono estranei, più mi intrigano. A me eccita la novità che ogni vino, che ogni decilitro di quel vino stappato, versato e bevuto, sa regalarmi. È questa mai sopita epifania sensoriale, figlia della fermentazione di uva sana, che mi fa ogni volta ringraziare il destino per avermi concesso l’opportunità di fare questo mestiere, il mestiere del degustatore.
Proprio per le ragioni che ho appena espresso, trovo un’occasione mancata l’assaggio di quei vini che rinunciano alla loro diversità e che dunque mi vietano l’opportunità di scoprire cose nuove, di conoscere, di imparare, di eccitarmi. Trovo irritanti non i piccoli vini, che anzi ricerco per la mia tavola, ma i vini “plastificati”, i vini “intonacati”, i vini “botulinizzati”, che esibiscono la loro materia, sbraitano la loro ambizione, si specchiano nella loro rassicurante perfezione formale, senza essere nient’altro che il risultato tecnologico di un protocollo. Senza essere nient’altro che un copiaincolla.
Tutto ciò che sta nei pressi del protocollo, della serialità, della pigrizia intellettuale, della ripetizione industriale di un modello si scontra brutalmente con ciò che del vino mi piace, con ciò che del vino amo: la sua originalità e la sua bellezza. Un vino omologato ha abdicato al suo mandato geografico, che è dialogare con suo il territorio d’origine; ha abdicato al suo mandato filosofico, che è lasciar intuire la personalità degli uomini e le donne che lo hanno concepito; ha abdicato al suo mandato sensoriale, che è esprimere delle originalità non replicabili altrove; ha abdicato al suo mandato gastronomico, che è servire la tavola, dimostrando versatilità negli abbinamenti. Il vino omologato, prodotto avendo a cuore solo le esigenze del mercato (e della finanza, del marketing, dell’immagine) ha smarrito ogni ipotesi di originalità e sciupato ogni bellezza possibile.

Si dirà: c’è un modo per affermarla come valore in sé, la bellezza? Forse sì, là dove si intenda bello anche ciò che sia buono e ciò che sia vero, essendo il bello, il buono e il vero tre valori riferiti alla medesima unità di senso. In capo a questo principio, non c’è bellezza senza bontà e verità: se ciò che è buono non è anche bello e vero, allora è meno buono; se ciò che è vero non è anche bello e buono, allora non è poi così vero; e se ciò che è bello non è anche vero e buono, forse non è davvero bello.
La bellezza isolata è culto dell’apparenza, dell’effimero, del piacere superficiale; la bontà isolata è sapore senza sapere, passione come fuoco di paglia, godimento incivile; la verità isolata è una procedura dimostrativa che non sostiene l’eccezione, la contraddizione, l’indicibile, e dunque le umanità più umane. La bellezza che tiene in considerazione anche il vero e il buono ricorda la luce, inonda di luce la vita e le cose della vita. È un talento che tutti possiamo riconoscere, a patto di educarci al suo riconoscimento, alla sua scintilla, alla varietà dei suoi colori.
La bellezza è il riflesso della luce, che a sua volta è energia, perché senza energia non c’è luce; la bellezza è anche verità, perché senza verità non c’è energia e non c’è luce. Quando un vino possiede la luce, l’energia e la verità, allora sfoggia anche un sapore forte, autentico, che tiene desta l’attenzione del degustatore. In questa catena di bellezza non si parla di proporzione, di coerenza, di armonia; la bellezza non è un ideale moderno di definizione; la bellezza non è invito alla perfezione. La bellezza autentica è semmai un inno alla misura e alla vita, a ciò che è umano e non industriale. Un vino industriale è liquido “morto” per necessità di filiera e mai potrà essere bello. In tal senso un vino è bello se è vitale, se concepito con l’amore per le cose che respirano, se si lascia attraversare dalla varietà della vita, dai suoi colori, dai suoi profumi, dai suoi sapori, dalle sue asimmetrie, dalle sue imprevedibilità; elementi che non possono essere surrogati da coadiuvanti, additivi e macchine.
Non può essere bello ciò che ha a che fare con l’uniformità, che è per antonomasia negazione della varietà, dei colori e della luce. Tanti vini vengono costruiti per essere identici l’uno all’altro, depurati di ogni tratto vitale, sterilizzati dalle tecniche più aggressive. Quel vino tecnologico, meccanicistico, seriale, è prodotto dalla più piccola delle imprese agricole e dal più gigantesco degli enopoli, perché non è nei numeri che si misura la vita. Quel vino fedele ai protocolli più rigidi, estraneo alle sfumature, è brutto, non bello. Lo standard è brutto, sempre. Al contrario, la bellezza si può apprezzare seguendo traiettorie ben altrimenti originali. Non è un caso che ci si possa innamorare di uno sfregio all’altezza degli occhi, di un sorriso sghembo, di una voce roca, di alcune cicatrici intime.

A proposito di intimità. Di bottiglia in bottiglia e di calice in calice si impara che a dispetto di quanto si dice e si scrive, la degustazione non regala mai un ritratto definitivo del vino. È ontologicamente reale ciò che esiste indipendentemente dal soggetto conoscente, e il vino non esiste senza di noi, il vino siamo noi, c’è un vino per ognuno di noi, per ogni degustatore possibile.
La degustazione è dunque sempre parziale e prova a intuire un solo momento di quel vino, una frazione della sua esistenza. Il respiro di ogni vino possibile, anche del vino più buono, anche del vino più solido, del più strutturato, del più agile, del più alcolico, del più acido, del più colorato, del più tenero, del più tenace, del più ruvido, del più lieve, del più chiuso, del più aperto, è troppo fragile e intermittente per essere permanente. E così tutto appare attraente quanto aleatorio.
Sarà per la mia cronica incapacità di trarre conclusioni credibili dalla degustazione; sarà che la degustazione mi tiene sempre a distanza da ogni più piccola certezza; sarà che la degustazione è per me uno spinoso covo di dubbi; sarà che sono un degustatore mediocre e magari sarà per tutte queste ragioni messe assieme, fatto sta che per me la degustazione, di tutti i vini in generale e di certuni in particolare, non mette in luce le cose, ma le tiene al buio. Stando così la (mia) faccenda col vino, la degustazione potrebbe equivalere a vivere per alcuni attimi in stanze oscure, tante quante sono i vini che si degustano; stanze da abitare come pipistrelli, lasciando che gli occhi si abituino alle tenebre per provare a distinguere qualcosa. A frequentare le tenebre si percepisce che i vini hanno sempre una faccia nascosta che vale quanto quella scoperta; che essi possiedono sempre un lato sotterraneo che fluttua in silenzio, sospeso, come un’icona bizantina. Il paradosso finale è che il più delle volte proprio in quelle condizioni claustrofobiche il misterioso senso del vino prova a compiersi o quantomeno a farsi intuire. Come se il suo sapore e il suo insapore, il suo bello e il suo brutto abitassero sempre dalla parte opposta della luce; come se solo nel buio gli umori sappiano farsi percepire. A una condizione: abituare i propri sensi a orientarsi senza una lampadina, senza una candela, niente di niente.
Ecco, se le cose stessero davvero così, se la degustazione incontrasse proprio nel buio la sua ipotesi più credibile, allora è probabile che la qualità necessaria a un degustatore (la sua stella polare, la sua bussola) sia la pazienza (e non temere l’oscurità, naturalmente). La pazienza di attendere che il vino si faccia nello spazio, nel tempo e negli imprevisti. La pazienza di accettare che il vino mai si compirà nella perfezione, se per perfezione si intende la mancanza di qualsiasi contrattempo. La pazienza di imparare che la lentezza, come il buio, ti abitua alla profondità, che è parecchio meno puttana della superficialità.
Che poi, in verità, quando si inizia ad assaggiare, da neofiti, tutto appare superficiale e ai primi sorsi si dirà che è solo un vino, che per quanto buono, buonissimo, ottimo, mirabile, solo di vino si tratta. I primi calici bevuti dissimuleranno molto, si giustapporranno gli uni agli altri, sembreranno tutti uguali. Poi, a un certo punto, con un po’ di pratica, un po’ di conoscenza, le giuste letture, qualche viaggio, il continuo confronto e un’assidua scoperta, quei calici cambieranno significato, l’emozione salirà irresistibile e la diga dei sentimenti risulterà infranta, inesorabilmente. Inizierà così, per gioco, la passione “colta” intorno al vino. Da quel momento il vino diventerà un “liquido luna park”: certo non mancherà qualche giostra preferita, ma sarà l’intera, inesauribile possibilità di scelta, a creare dipendenza (non dall’alcol, dai sentimenti).
Allora diventerà proprio impossibile rispondere alla domanda: “qual è il vino migliore?”, perché non esiste il vino migliore. Ogni vino avrà diritto di cittadinanza nei sensi del bevitore coltivato: il vino fiammeggiante e il vino taciturno, il vino scapigliato e il vino impeccabile, il vino ruvido e il vino languido, il vino ruspante e il vino raffinato. Tanto più la “scimmia” della passione reclamerà spazio nel cuore dell’enofilo, tanto più insopportabile sarà scegliere, schierarsi, parteggiare, tifare per un vino o per l’altro, per un territorio o per l’altro, per uno stile o per l’altro; tanto più ci si allontanerà dalla superficialità dell’approccio, tanto meno si diventerà perentori nell’approdo.

Quel che invece diventerà indispensabile sarà trovare le parole, per parlare di quel vino, di quel vino lì, proprio di quello e di nessun altro; il vino di quel produttore, di quel millesimo, di quel flacone stappato e assaggiato in quel momento, in quelle condizioni ambientali e sentimentali, certi che la degustazione è solo un’istantanea condizionata da innumerevoli fattori esterni e interni, umani e naturali, probabili e improbabili. E che nulla l’indomani sarà più lo stesso.
Le parole del vino possono percorrere molte strade, tante quante sono le numerose variazioni del liquido odoroso, tante quante sono le infinite variazioni umane. Del vino ne può parlare usando un atlante topografico, oppure un manuale di enologia e agronomia, altrimenti una guida, un libro, un saggio, una raccolta di interviste, e via così all’infinito. Ciò che tuttavia conta per davvero, è saperle scegliere quelle parole. A noi piacciono le parole di uso perlopiù quotidiano, adoperate da tutti, in qualsiasi contesto della vita. Lemmi che possono servire a esplorare il vino dal punto di vista di chi produce, di chi degusta e di chi critica, senza limiti di estrazione e di formazione. Parole mai selettive e anzi disponibili a chiunque, di cui tutti abbiamo la titolarità, che ciascuno di noi può comprendere e utilizzare.

Per questo motivo mi persuadono meno i termini specialistici: a mio avviso sono poco utili al sapere degli operatori (che già ne conoscono il significato) e spesso scoraggianti per i non addetti ai lavori. Suggerisco pertanto di dare voce alla normalità e alla semplicità del lessico, per tentare di togliere la lingua del vino dalle sabbie mobili del tecnicismo, provando a restituirle un sapore umano. Consiglio di aprire più porte possibili ai valori e alle relazioni che portano il vino nei pressi di ciò che siamo, perché la vita di un vero appassionato è impastata di vino.
Ma si badi bene, non occorre essere linguisti o filologi per regalare le giuste parole al vino, mentre lo degustiamo. Basta aprirsi all’intelligenza e temere la noia, stando nella trincea delle cose, con lo zaino in spalla e la curiosità eternamente accesa, affidandosi alla filosofia dei sensi, consapevoli che niente accadrà una seconda volta. Un profumo e un gusto, una sensazione e una riflessione possono emergere come un lampo e poi estinguersi bruscamente, per ragioni pressoché imprevedibili, come imprevedibili sono quelle giornate di marzo, in cui il sole si alterna alla pioggia e il caldo al freddo, senza alcun preavviso.




