E’ con immenso piacere che accogliamo un personaggio del calibro di Daniel Thomases nel nostro gruppo. Dopo l’arrivo circa due anni fa di Francesco Falcone continua la “piacevole migrazione” di grandi firme del giornalismo enoico italiano verso il nostro piccolo giornale online, che tanto piccolo non è. E’ quindi anche con pizzico di orgoglio che gli diamo il benvenuto, certi che il lavoro e la serietà mostrata negli anni paghino. Benvenuto Daniel!

Poche cose nel mondo del Chianti Classico sono più evidenti e importanti del ritorno ai vini di denominazione e, soprattutto – finalmente – del nuovo apprezzamento del sangiovese come garanzia della toscanità di questi. Si potrebbe benissimo dire, infatti, che stiamo entrando nella quarta fase di una storia, iniziata nel 1967, piuttosto tormentata nelle prime fasi ma che ora offre la possibilità di vedere luce in fondo al tunnel, il classico “happy end” hollywoodiano.
Questi pensieri sono stati ispirati da una degustazione comparativa di campioni di diversi vini delle aziende agricole prodotti dalla Marchesi Antinori S.p.a. Torno indietro però per meglio spiegare il sopracitato concetto delle fasi che hanno contraddistinto questa denominazione dal 1967 quando, il 9 agosto, fu approvata la DOC originale.
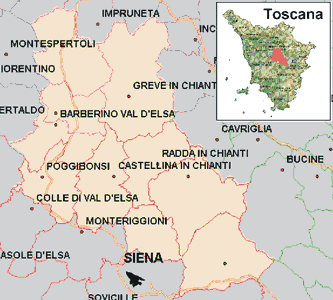
La prima fase
La prima, che potrebbe essere calcolata come il quindicennio fra il 1967 e il 1982, fu contraddistinta da produzioni molto generose, 115 quintali di uva/ettaro e anche di più in quanto le sovrapproduzioni non penalizzavano il vino DOC, potevano essere vendute come vino da tavola. Poiché i vigneti, piantati con i criteri (si fa per dire) del programma FEOGA consistevano in poco più di 2700 ceppi per ettaro (che ovviamente diventavano meno con il passare degli anni, causa la normale mortalità delle viti), non è difficile – poiché la matematica non è un’opinione – capire che le produzioni per ceppo erano all’incirca di 5 chilogrammi e anche di più, livello incompatibile con una buona maturazione di qualsiasi uva, figuriamoci per il sangiovese. In quel momento il materiale genetico non era stato selezionato in base a criteri qualitativi, cloni interessanti e importanti non esistevano proprio e quasi tutto era innestato sul portainnesto Kober 5BB, la cui grande spinta era necessaria per arrivare alle produzioni per vite dell’epoca. La percentuale del sangiovese poteva essere, al massimo, l’80%, ma poteva pure essere solo il 50%, e non era neanche contemplata la possibilità di un Chianti Classico al 100% sangiovese, sarebbe stato un fuorilegge.

Morale della favola: vini di poca consistenza e personalità, leggeri e beverini (la vera vocazione della zona secondo molti in quel periodo), pallidi di colore; caratteristiche aggravate dalla presenza del canaiolo (almeno il 10%) e soprattutto di uva bianca (obbligatoriamente il 10-30%!). Questo Chianti Classico rimaneva nelle cantine, le quali, alla fine degli anni ’70 e agli inizi degli anni ’80, scoppiavano di vino invenduto e invendibile, nessuno voleva questa roba.
L’evoluzione
La seconda fase, su per giù il quindicennio fra il 1985 e il 2000 che seguiva l’approvazione della DOCG del 1984, tentava di porre rimedio alla situazione critica che si era creata, raddrizzare una barca che prendeva acqua da tutte le parti, introducendo migliorie al disciplinare, sicuramente utili e significative. La percentuale massima di sangiovese saliva quasi al 100%, mentre quella delle uve bianche scendeva ad un (risibile) 2%, della serie “All’inizio abbiamo fatto un grosso errore ma non vogliamo ammetterlo. Il trebbiano e malvasia ci devono essere, sebbene solo simbolicamente”. Una maggiore fittezza nei vigneti non fu resa obbligatoria in quel momento, ma le pessime vigne della prima fase, via via che dovevano essere ripiantate, venivano rimpiazzate da impianti più compatibili con una viticoltura di qualità.

Allo stesso tempo, però, c’era un ricorso massiccio all’utilizzo di vitigni alloctoni per nulla tradizionali, innanzitutto i bordolesi (cabernet e merlot, ovviamente) che cambiavano radicalmente i profumi e sapori, il corpo e i tannini, dei vini. Insieme ad un altrettanto massiccio ricorso all’impiego per l’affinamento di legni francesi di piccole dimensioni, formati con un impatto radicale sulla personalità di vini il cui carattere precipuo è sempre stato la finezza e fragranza. La perdita di identità è stata molto importante e, come succede spesso in questi casi, bisogna domandarsi se la toppa non fosse peggiore del buco, anche se questa soluzione – la così detta “internazionalizzazione” di questi vini – ha indubbiamente ridato un posto nei mercati di qualità del mondo, cosa impossibile con i Chianti Classico della prima DOC. Ma l’internazionalità è uno stile, un’ampiezza e profondità unita ad una buona morbidezza e rotondità, che nulla ha a che vedere con la presenza o assenza di determinate varietà di uva o l’utilizzo di contenitori di rovere di capacità ridotte.
Il ritorno
Ma, come ci ha insegnato Giambattista Vico, la storia consiste di corsi e ricorsi, e il quindicennio fra il 2000 e il 2015 (a giudicare dalla annate già commercializzate, ma pare improbabile che le prossime, 2016-2018, dimostreranno un cambiamento di tendenza) ha visto un ritorno – molto benvenuto fra l’altro – al sangiovese molto significativo e un diminuzione, altrettanto gradevole, dei vitigni “internazionali”. Assieme a, per l’affinamento dei vini, un nuovo apprezzamento della botte e del tonneau da 500-700 litri a svantaggio della barrique. “Territorio” è ormai la parola in bocca a tutti, ma l’espressione del territorio chiaramente dipende da una viticoltura rigorosa, ora presente grazie ai nuovi impianti e alle conoscenze acquisite negli ultimi decenni, e da un’enologia corretta, non invasiva, che cerca di far esprimere le specificità dei singoli siti anziché assoggettarle a schemi preconcetti e pratiche standardizzate e standardizzanti. E, in primis, da un nuovo rispetto per il sangiovese come sinonimo della Toscana e della toscanità vitivinicola.

Ma c’entra anche una consapevolezza che nominare il vitigno è soltanto il primo passo in quanto le varietà importanti si esprimono diversamente nei singoli terroir: nel Médoc, ad esempio, il cabernet del comune di Margaux, piantato su suoli con una maggiore percentuale di sabbia rispetto ad altre zone, è più fine ma anche più fragrante di altre espressioni del vitigno, mentre quello coltivato sui terreni argillosi di Sainte-Estèphe è più concentrato e potente, ma anche più tannico. E, per continuare il discorso, il pinot nero di Chambolle-Musigny, di nuovo su terreni piuttosto sabbiosi, dimostra eleganza e aromaticità mentre quello di Gevrey-Chambertin, dove c’è molto più scheletro, è, pur nel contesto di una varietà piuttosto “femminile”, più tannico e intenso.
Sottozone?
Non credo che arriveremo a sottozone comunali nel Chianti Classico, i comuni stessi sono molto più estesi rispetto a quelli francesi e sono molto più variegati al loro interno per quanto riguarda suoli, esposizioni e altitudini: il Médoc, ad esempio, è piatto quindi i fattori esposizione e altitudine non c’entrano e nella Côte d’Or le esposizioni sono quasi universalmente a sudest. Detto questo, ci sono diverse aree di una maggiore estensione di quella di una singola azienda agricola con una certa omogeneità che poi si trova nei vini, solo per citare un esempio quella piaggia che scende da Castellina paese (strada chiantigiana 222) verso Castellina Scalo (strada 51), le esposizioni sono a sudovest, le zone vitate sono protette dai venti e dall’aria fredda dalle colline alle spalle dei vigneti, che tendono a produrre un sangiovese di corpo, ampiezza e calore. E ci sono sicuramente altre aree di questo tipo che potrebbero essere identificate senza difficoltà come – altro esempio – la sottozona che, a sud di San Donato in Poggio, scorre lungo la via della Paneretta e passa davanti ad Isole e Olena, il Castello della Paneretta e il Castello di Monsanto per terminare alla Fattoria di Cinciano e alla Fattoria Le Fonti.

Antinori
Torniamo a questo punto ad Antinori, una delle storiche case vinicole del Chianti Classico ma, un mezzo secolo fa, non una delle maggiori e comunque di minore importanza per quanto riguardava i volumi della Ricasoli, della Ruffino e della Melini. Oggi, invece, questi numeri sono stati ribaltati e gli Antinori, fra la Marchesi Antinori e le varie tenute di proprietà, producono all’incirca una ventina milioni di bottiglie e sono presente in una serie di regioni che spaziano dalla Puglia all’Umbria e alla Toscana e poi alla Lombardia e Piemonte. Tutto il paese in poche parole: il Sud, il Centro e il Nord.
L’espansione, però, iniziò piuttosto tardi, negli anni ’60 e ’70 l’azienda rimaneva ancorata alla sua base d’origine nel centro della Toscana e i primi acquisti, fra la metà e la fine degli anni ’80, non si discostavano di molto: Péppoli, vicinissimo all’allora tenuta di Santa Cristina e poi la Badia di Passignano a Tavarnelle Val di Pesa. E persino il primo lustro degli ’90 non vedeva investimenti nella storica parte centrale della Toscana, bensì nel sudest (Montepulciano e Cortona), il sud (Montalcino) e, massicciamente, sulla costa (a Castiglione della Pescaia, Sovana, per non parlare di un importante ingrandimento della superficie vitata a Bolgheri, dove attualmente ci sono addirittura 300 ettari di vigneto).

Invece c’è stato ultimamente, nel nuovo millennio, un importante ampliamento del potenziale produttivo sia a Péppoli, dove la casa produce il suo Chianti d’annata, che alla Tenuta Tignanello (il nuovo nome per Santa Cristina, ormai impiegata per una gamma di vini – bianco, rosso, rosé e Vin Santo – prodotti nella cantina di Cortona) e alla Badia di Passignano. E, mossa che ha ispirato questo articolo, l’acquisto per la prima volta di vigne nel Chianti Classico senese, a Gaiole in Chianti e a Castellina in Chianti.
Per essere precisi del Castello di San Sano a Gaiole, comprato nel 2014 e, nel 2016, di Capraia a Castellina, l’ultima proprietà ribattezzata Tenuta Casa di Pietra. Entrambi appartenevano prima a Calogero Calì, proprietario della Rocca di Castagnoli, in passato proprietà ricasoliana, a Gaiole. Nessuna decisione finale è stata presa, ma pare ci sia l’intenzione, a partire della vendemmia 2017, di produrre selezioni che saranno commercializzate come Chianti Classico Riserva, e l’orientamento è di produrre vini al 100% sangiovese, in un certo senso un ritorno alle origini. I primi – e rivoluzionari – Tignanello, il 1970 e il 1971, eliminavano il trebbiano dal blend e riducevano la malvasia al 3%. L’eccezionale 1971 era per me molto meglio del 1975, che ha aggiunto per la prima volta al taglio il cabernet. Inutile rammaricarsi di percorsi non seguiti, di ciò che sarebbe potuto essere: una denominazione che avrebbe puntato tutto sulla grande varietà autoctona. Ma fortunatamente nel vino, come nella vita, c’è sempre la possibilità di riconsiderare tutto e di ripartire.

Essendo al corrente di questi nuovi poli produttivi, ho chiesto a Renzo Cotarella, direttore ed enologo, la possibilità di degustare in confronto i quattro maggiori sangiovese chiantigiani – Tignanello, Badia a Passignano, San Sano e Casa di Pietra – della Antinori. Richiesta gentilmente accettata e la degustazione, in presenza di Cotarella, ha avuto luogo a fine marzo. Le note della degustazione sono volutamente telegrafiche, non amo quelle che sembrano voler sfidare Guerra e Pace, e sono state pure aggiunte le informazioni basilari sulle singole tenute d’origine.
San Sano
L’azienda si trova nella parte occidentale del comune di Gaiole in Chianti fra il Castello di Ama al nord e Il Palazzino al sud. La quota è la più alta fra le diverse tenute di proprietà in Chianti Classico, fra il 340 e il 420 metri s.l.m. Le esposizioni sono tendenzialmente a sud-sudest e i suoli, sebbene con una buona presenza di argilla in profondità, sono molto ricchi di scheletro, per lo più galestro e alberese. Il microclima, causa l’esposizione, calda ma meno di un sudovest, insieme con altitudine e l’importante presenza di scheletro, danno un sangiovese decisamente elegante, con un tannino molto fine; forse non “da Pinot Nero”, come sovente si dice, ma sicuramente un po’ borgognone se analizziamo la levigatezza della trama. Per questo motivo è affinato solo in tonneau senza alcuna presenza dei legni piccoli.

Chianti Classico Riserva 2017 (campione in affinamento)
Rosso rubino di buona brillantezza il colore, media la profondità e densità tonale come è giusto per un sangiovese che nasce a queste altitudini, l’impenetrabilità non può essere una delle caratteristiche. Molto fragrante al naso, dove dominano la fragola e il ribes rosso, più leggera la suggestione della ciliegia, leggere pure le spezie del rovere, sentite e non sentite e ottimamente fuse con il resto, la finezza è e deve essere il privilegio di questo vino. Lungo e continuo al palato, il corpo è medio ma ben sostenuto da tannini di carattere filigrana che appoggiano e danno slancio all’assaggio, setoso e ben levigato: indiscutibile la personalità varietale, il timbro territoriale, molto Gaiole alto del sangiovese che nasce sul ricco scheletro di alberese e galestro.
Casa di Pietra
A differenza del Castello di San Sano, la tenuta Casa di Pietra è quella a quota più bassa, fra il 280 e il 320 metri s.l.m., tra le proprietà in Chianti Classico degli Antinori. L’esposizione è a sudovest, e questa, assieme all’altitudine relativamente bassa per la denominazione, fanno sì che le maturazioni siano complete e piuttosto precoci: a volte si comincia a vendemmiare più o meno alla stessa epoca di Montalcino, all’incirca 60 chilometri a sud. I terreni, sebbene con una buona dotazione di argilla, contengono anche sabbie tufacee e una media presenza di scheletro, principalmente l’alberello e galestro di Castellina in Chianti, e sono molto pendenti e drenanti. Il sangiovese prodotto è affinato sia in tonneau che in barrique.

Chianti Classico Riserva 2017 (campione in affinamento)
Del tutto diverso questo esemplare rispetto al precedente, più profondo e concentrato il colore, rubino pieno e scuro, e anche il frutto è più scuro e nero con le sue note di mora e marasca insieme ad una presenza più marcata del legno di affinamento, cannella, sandalo, chiodi di garofano, ma sempre in buon equilibrio con l’insieme aromatico. Maggiore anche il volume, la densità e intensità al palato, più maturo e dolce il frutto: poco o nulla dell’austerità del sangiovese di quote maggiori, ampia e solida la struttura. Vino che rispecchia sia il calore della zona che la presenza dell’argilla nel suolo, piuttosto ricco e potente per un Chianti Classico, ma per niente problematico di carattere.
Tenuta di Tignanello
La Tenuta Tignanello, sito a sud di Mercatale Val di Pesa e a sud-est di Montefiridoli è, in un certo senso, la casa madre antinoriana, il luogo storico dove tutto ebbe origine. E più recentemente, la proprietà dove sono nati vini come il Tignanello e il Solaia che, nonostante non siano Chianti Classico, hanno dato un nuovo lustro alla zona e i suoi vini. La selezione impiegata per il Tignanello proviene dal vigneto Tignanello nella parte alta della proprietà, mentre la Riserva Marchese Antinori nasce in una serie di altre particelle a diverse altitudini che sono pure di buona qualità; i suoli, in generale, sono molto galestrosi. Il sito è ben ventilato e il sangiovese prodotto abbina, in modo esemplare, l’eleganza e l’intensità che sono proprie della varietà quando coltivata e vinificata a regola d’arte; qui i tannini del vitigno, se mai squilibrati, si fanno sentire e danno carattere e identità. Come il sangiovese da Tignanello della tenuta, questa selezione è affinata nelle barrique.

Chianti Classico Riserva Marchese Antinori 2017 (campione in affinamento)
Rubino solido e sostenuto, brillante, meno ricco della Riserva Casa di Petra ma comunque di buona concentrazione. Molto espansivi i profumi con il lampone in primo piano, più defilati il ribes rosso e la ciliegia, deciso il contributo delle spezie ma senza eccessi, lunghi e ben continui gli aromi. Molto buone la densità e solidità della struttura, potente ma armonioso allo stesso tempo, l’intensità bilanciata da una buona dolcezza anche se l’austerità del sangiovese in terra galestrosa c’è ed è percettibile, una leggera granulosità al finale e al retrogusto. Il tannino di Tignanello è molto ben presente senza il contributo del cabernet e, per me, molto gradito.
Badia di Passignano
Come indica il nome, le vigne di questo storico monastero, che risale alla metà del undicesimo secolo e dove un certo Galileo Galilei insegnava matematica verso la fine del ‘500, circondano l’abbazia e si trovano all’incirca a 300 metri di altitudine su suoli galestrosi. Siamo in un lembo un po’ dislocato rispetto al resto della zona di produzione, a Tavernelle Val di Pesa nella parte ovest della DOCG.

L’abbazia, che ospita pure la cantina di affinamento dei vini, si trova in cima della salita che, prima di Sambuca parte dalla Strada della Pesa che scorre parallela alla superstrada Firenze-Siena. Ampio e ricco, ma allo stesso tempo molto fragrante, il vino è affinato solo in tonneau per non prevaricare queste caratteristiche, e più recentemente sono state introdotti legni ungheresi, la cui dolcezza e ridotto impatto sul vino si fanno sentire. I vigneti – piantati, come alla Tenuta Tignanello, con selezioni aziendali operate con il grande vivaista Guillaume della Borgogna, datano dal 1994 benché la terra fosse stata acquistata nel 1987 – partono da sotto il monastero e continuano oltre la badia verso Montefioralle dove le quote sono più alte.
Chianti Classico Gran Selezione 2017 (campione in affinamento)
Il più ricco e, allo stesso tempo, il più elegante di questo quartetto, grande e molto espansiva la fragranza e la complessità aromatica, molto importante l’estratto ma molto vellutate le sensazioni tattili, ampia e morbida la struttura, con una densità e intensità superiori che riempie la bocca senza appesantirla, sontuoso e dolce ma pure di grande eleganza, velluto puro sulla progressione e al finale. Tannini e equilibro di un calibro davvero superiore, classe e razza da vendere: da anni uno dei grandi vini del Chianti Classico e non solo, stranamente e inspiegabilmente trascurato e ignorato dalla stampa specializzata.




