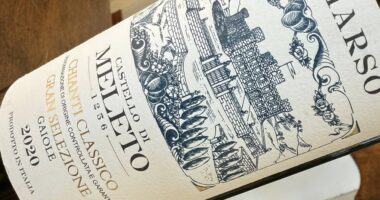Credo non siano in molti gli italiani che, d’acchito, sappiano indicare dove si collochi il Canavese. E ancor meno quelli che conoscano l’Erbaluce di Caluso, vitigno dal nome evocativo tipico della zona del Piemonte compresa tra Torino e la Val d’Aosta. Probabilmente in pochi, locali esclusi, sanno poi che l’Erbaluce è detta anche Greco Novarese. Un’uva pochissimo diffusa fuori da quel circondario: chi se ne intende racconta che in passato, ma ora non più, si coltivava anche nel Monferrato e che il sistema di coltivazione è la caratteristica pergola canavese, quasi a tendone, pensata per catturare al meglio la luce solare e nutrire i grappoli vigorosi, dalla buccia spessa e croccante, tendenzialmente tardivi, di modesto potenziale alcoolico ma con alta acidità naturale.
Gran parte dei vigneti risalgono ancora agli anni ’60 e sono il frutto della selezione massale fatta allora. L’Erbaluce, del resto, è stata a lungo la classica uva fatta appassire nei solai e poi vinificata in casa per un consumo domestico, tendenzialmente festivo, ma tra alterne fortune e timidi tentativi di espansione è rimasta più o meno in ombra fino agli anni 2000, quando l’acidità dei vini è tornata di moda e il vitigno si è affacciato con successo sul mercato dei bianchi fermi e gli spumanti, soprattutto metodo classico, di cui in giro si assaggiano in effetti ottimi prodotti. Segnalo tra i secondi la Gran Cuvee Erbaluce di Caluso docg della Tenuta Roletto (senza annata), un brut con il 50% di vino di riserva e 24 mesi sui lieviti: color oro brillante, spuma ricca e fine, un bouquet complesso, pieno di sfumature e di freschezza e un palato morbido e pastoso, con bella scia acida, sapido e lungo. Tra i primi mi è piaciuto il Reiri, Erbaluce di Caluso docg 2023: fatto con uve vendemmiate più tardi della norma, spicca all’olfatto per la florealità e un bel frutto maturo, con accenni di zolfo e pietra focaia che tornano in bocca con una bella tattilità, acidità spiccata ma senza eccessi e una inattesa tannicità.

Ero invece personalmente abbastanza a digiuno di Erbaluce passito, sebbene come detto questo tipo sia il più tradizionale: pigiati gli acini appassiti (coi grappoli appesi a testa in giù per agevolarne l’areazione), in passato il mosto veniva messo in botti di acacia o di castagno e lì lasciato a maturare per molti anni, dando vita a un vino parecchio ossidativo. Più di recente – mi spiegano Lorenzo Simone, vicepresidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Docg Caluso, Doc Carema e Canavese, e l’enologo Gianpiero Gerbi – si sono un po’ accorciati gli affinamenti, scesi a 6/8 anni, e si è passati a botti di rovere e a una maggiore attenzione per la botrite nobile.
Ho potuto approfondire l’argomento di recente testando un paio di questi cosiddetti “Sauternes di Caluso”, che ho trovato decisamente interessanti. Anzi, intriganti e, a mio modestissimo parere, più che meritevoli di essere valorizzati nell’asfittico mercato dei passiti, grazie a un gusto caratteristico, non stucchevole, profondo, in qualche modo “tentatore”, e a un buon rapporto qualità/prezzo (costano tra i 12 e i 17 euro + iva).
Il primo è Sulè, Caluso Passito docg 2022 di Orsolani: di colore arancione scuro, quasi ambrato, al naso ha una mancata nota ossidativa e richiami dolciastri, per poi virare nettamente su sentori di mandorla e di nocciola che tornano anche al palato, dove la dolcezza non esonda e rimane pulita, quasi asciutta.

Il secondo è il Bohemien, Caluso Passito docg 2019 di Tappero Merlo: all’occhio ricorda le tonalità del miele di castagno, mentre all’olfatto è gentile, composto, con richiami di frutta secca. Il bocca il vino è ricco, ampio, gradevolmente dolce ma senza alcuna stucchevolezza e il sorso dona un’equilibrata lunghezza.
Da farne scorta per l’autunno.