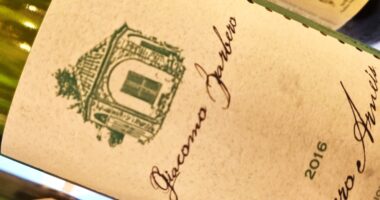Parlare oggi di lambrusco, anzi di lambruschi, è un po’ come parlare delle nuvole in cielo: sono infinite e in continua mutazione ed è difficile se non impossibile dargli una definizione precisa. Se è grammaticalmente sbagliato mettere un vino al plurale nel caso dei lambruschi in certi casi è quasi doveroso perché il panorama è talmente ampio e variegato che è difficile raggrupparli sotto le stesso ombrello.
Il frastagliato mondo dei lambruschi
Guardando “il cielo” dei lambruschi e dopo averne degustati quasi 160 quello che abbiamo detto sopra è il sunto che viene fuori: siamo infatti in un mondo dove si incontrano realtà di altissima qualità accanto a produttori interamente orientati verso mercati da grandi e grandissimi numeri, dove il prezzo deve essere giocoforza basso e la qualità purtroppo non risulta certo elevata.
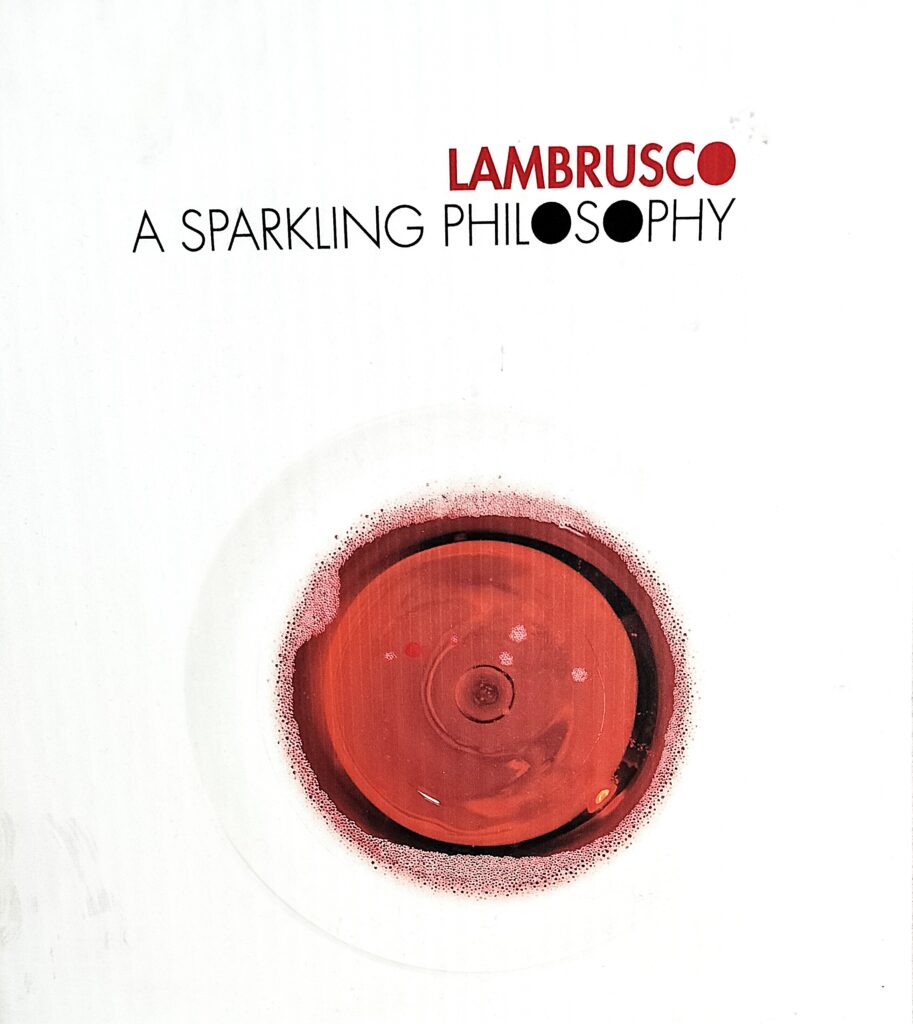
Ma questo, in maniera diversa, accade un po’ in ogni territorio che si rispetti: quello che differenzia le terre del lambrusco è l’estrema e quasi infinita frammentazione di denominazioni e tipologie che rende difficile anche a chi è del settore capire cosa si può trovare dietro a un’etichetta. Le differenze tra ancestrale, secco, frizzante, spumante (naturalmente o brut o extra brut o pas dosé), amabile, extra dry, sono solo il secondo scoglio da superare, il primo è quello delle quasi dieci DOC e il mare di Emilia IGP, dove per sovrappiù si possono trovare tranquillamente dei lambrusco rosso di colorazione rosa (più o meno intenso) e dei lambrusco rosa con colorazioni vicine al rosso rubino.
Sono convinto che questo coacervo di DOC, IGP, tipologie, menzioni vi abbia creato una certa confusione in testa, la stessa che ha creato a noi e a cui aggiungiamo il “carico da 11”, cioè che in queste terre coesistono sempre più difficilmente le cantine cooperative più grosse d’Italia e produttori di nicchia che sfiorano a malapena le 10.000 bottiglie.

Quantità o qualità? Due strade ugualmente rispettabili ma molto diverse
Prima di presentarvi i risultati singolarmente sono d’obbligo due parole sia sulle ultime annate e sulla situazione generale del prezzi delle uve e quindi dei vini. Sia la 2024 che 2023 purtroppo non sono state di alto livello: piogge e conseguenti problemi sanitari delle uve hanno permesso in non molti casi di portare ottime uve in cantina. Questo ha inciso anche sulle rese che per le aziende migliori, sono lontanissime da quei 170/180 quintali a ettaro che i disciplinari permettono. A diminuire le rese ci stanno pensando, purtroppo anche la flavescenza dorata e il mal dell’esca che, specie nel mondo del Sorbara, stanno radendo al suolo interi vigneti. Tutto questo per dirvi che negli ultimi due anni se volevi fare qualità e magari hai vigneti di collina arrivare alle rese da disciplinare è stato quasi impossibile. Però il discorso cambia se sei un conferitore di cantina sociale, magari hai vigne in pianura e sai che nella migliore delle ipotesi l’uva (se per vino DOC, per IGT i prezzi sono più bassi) ti verrà pagata 40/50 euro al quintale ma molto spesso scendendo fino a 25/30 . In questo caso devi produrre molto e la riprova è che nel 2024, annata non certo facile, i 170 quintali a ettaro (specie in pianura) sono stati raggiunti. A questo aggiungici un aumento della produzione che è andata dal quasi 10% per i lambruschi al 20% per l’ancellotta. Come vedete la forbice tra quantità e qualità è dettata da fattori contingenti ma comunque reale.

Ma adesso resettiamo tutto e cerchiamo di presentare in maniera il più chiara possibile i Lambrusco (torno al singolare) dei nostri assaggi. Come potrete vedere anche andando sulla guida abbiamo diviso in tre parti la degustazione: quella che riguarda i Lambrusco di Sorbara DOC (e i vini fatti con uve sorbara 100%) , i lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC (e i vini fatti con grasparossa 100%) e un terzo gruppo dove troviamo sia Lambrusco reggiano DOC, altre DOC con numeri nettamente inferiori (Lambrusco Salamino di Santa Croce, per esempio) e i molti Emilia IGT.
Lambrusco di Sorbara
Il Sorbara è sicuramente l’uva che nell’immaginario collettivo di quelli che amano il lambrusco e hanno qualche annetto sulle spalle incarna questo vino. La sua austera freschezza, la sua finezza aromatica, la sua bolla stuzzicante affiancata da una scarsa presenza tannica ne fanno l’icona su cui non si discute. Purtroppo invece un po’ bisogna discuterne, partendo dai colori che oramai vanno dal rosa buccia di cipolla al rubino intenso, creando una certa confusione accentuata dal fatto che ci sono rosati più rossi di tanti rossi. Questa confusione cromatica non facilita certo l’approccio ai vini, oramai sempre più “divisi” tra frizzanti e spumanti, millesimati o meno. Assaggiare oggi dei Sorbara vuol dire non fermarsi ad un’annata ma spaziare attraverso cinque o sei e quindi parlarne in maniera trasversale. Sotto questo punto di vista ribadiamo che rispetto al passato (diciamo 5-6 anni fa) troviamo una qualità media leggermente inferiore (pur se con picchi importanti) ma soprattutto una diaspora della tipologia, una mancanza di uniformità che invece potrebbe aiutare maggiormente la commercializzazione. Tra i migliori troviamo comunque le stimmate del vitigno e quella beva sapida ed estremamente soddisfacente che i grandi Sorbara non possono non avere. Voto alla tipologia 6.5

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Se nel nostro immaginario il Sorbara può essere identificato con una donna bella e fine, il Lambrusco Grasparossa viene visto nel ruolo del maschio giovane e muscoloso. Fuor di metafora il Grasparossa ha caratteristiche più intense, a partire dal colore, per arrivare ad una tannicità importante passando attraverso profumi intensi e netti di frutta rossa e di bosco. Da questi parametri generali i Grasparossa degustati non si sono allontanati molto, dimostrando una coerenza alla tipologia che oggi è unica nel mondo lambrusco. A questo si aggiunge una qualità media piuttosto alta che lo pone sul gradino più alto del podio dei nostri assaggi. Al contrario del Sorbara il Grasparossa, secondo noi, dà il suo meglio da giovane o giovanissimo, grazie ad un frutto spesso esplosivo e ad una tannicità viva ma non debordante o amara. Quando invece l’amaro prende il sopravvento, come in alcuni casi, la piacevolezza del vino va in picchiata e quindi diventa automaticamente figlia dell’annata. Sotto questo punto di vista la 2024 non è stata certo eccezionale e per questo il buon risultato assume ancor più valore. Voto alla tipologia 7.5
Reggiano, altre DOC e Emilia IGT
Qui si entra in un mondo diverso, che deve essere rispettato e capito, perché è quello dei numeri, del grande mercato di questo vino e spesso anche della sua immagine nel mondo. Abbiamo dovuto quindi riparametrarci un po’ nell’assaggio, sia perché si passa dal quasi totale monovitigno all’uvaggio, facendo entrare in campo lambruschi e uve (ancellotta in primis) che cambiano il quadro olfattivo e gustativo dei vini. Detto questo non possiamo certo essere soddisfatti di questa sezione dei nostri assaggi, perché in troppi casi abbiamo trovato vini con chiari problemi ( Brett in primis) che, specie in aziende dove la tecnica enologica è basilare, non dovrebbero essere presenti. Alcuni buoni prodotti sono venuti fuori e dobbiamo anche sottolineare i prezzi veramente molto bassi e altamente concorrenziali per tanti vini che propongono in diversi casi una qualità commisurata al prezzo, ma in generale il nostro giudizio qualitativo non può essere positivo proprio per quella “pancia problematica” che in soldoni rappresenta quasi il 30% dei vini degustati. Voto alla tipologia 5

In chiusura dobbiamo ringraziare sia il Consorzio del Lambrusco che la nuova associazione dei Custodi del Lambrusco per la grossa mano che ci hanno dato negli assaggi di quest’anno, permettendoci di assaggiare quasi il doppio dei vini degli anni scorsi. Abbiamo così potuto toccare con mano quante diversità vi siano in questo mondo e le difficoltà per poterle presentare nel modo migliore. Il problema è infatti una specie di Giano Bifronte, con due mondi che quasi sempre puntano a mercati diversi e guardano in direzioni opposte. Forse fondere i due modi di essere sarà difficile, ma sicuramente c’è lo spazio (speriamo anche la voglia) per poter fare squadra e presentarsi al mondo.