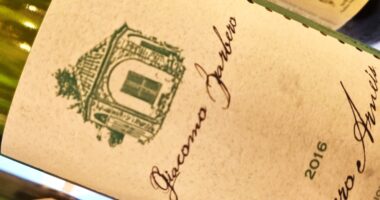Nei prossimi giorni pubblicheremo i risultati delle degustazioni di Chianti Classico annata (2023-2022) Riserva (2022-2021) e Gran Selezione (2022-2021). Prima però vogliamo fare un punto sulla sangiovesissazzione del territorio, cioè quanto sangiovese viene usato nelle tre tipologie di vini chiantigiani. Questo non per voler perorare nessuna causa ma solo per provare a far capire cosa c’è adesso e cosa è cambiato nell’arco di 10 anni.
Il Chianti Classico è terra di Sangiovese, ma è anche storicamente luogo dove vitigni come colorino, canaiolo, malvasia nera sono da sempre entrati nell’uvaggio del Chianti Classico.
Inoltre è la terra dove è stato piantato in buone quantità sin dai primi anni ‘80 prima cabernet sauvignon e poi merlot. Buona parte di queste uve andavano nei Supertuscan ma una discreta fetta (il disciplinare prevede tuttora un 20% per annata e riserva) si trovavano nei vini DOCG.
Negli ultimi 20 anni c’è stato, anche con l’avvento della Gran Selezione, una riscossa del sangiovese, sempre più usato in purezza nelle tre tipologie (annata, riserva, ma soprattutto Gran Selezione).

Dato che nelle schede richiediamo alle cantine le tipologie di uve presenti nei vini ogni tanto ci “divertiamo” (in realtà è un lavoraccio) a segnare le percentuali di uve vino per vino e poi tirare le somme di quanti vini, tipologia per tipologia, sono sangiovese in purezza oppure hanno anche un 20% di altre uve, autoctone o meno, nell’uvaggio. La prima volta l’abbiamo circa 10 anni fa, nel 2016 con i vini delle annate dal 2014 al 2012 e quindi ci sembrava il momento per rifare un punto della situazione dopo un giusto lasso di tempo, vedere se e cosa è cambiato nell’utilizzo dei sangiovese e degli altri vitigni piantati in Chianti Classico.
Non abbiamo dati precisi ma non crediamo che in questi quasi 10 anni la superficie vitata sia cambiata molto, invece per quanto riguarda i vini presi in esame sono sempre attorno ai 220 vini e alle 100 cantine, divisi nelle tre tipologie. Siamo i primi ad ammettere che non è un dato onnicomprensivo ma crediamo che siano comunque degli indicatori abbastanza rappresentativi.

Questi sono i dati del 2016
Chianti Classico annata Chianti Classico Riserva Gran Selezione Sangiovese in purezza 36-38% 42-43% 70-74% Sangiovese+altre uve 62-64% 57-58 % 26-30%
E questi quelli del 2025
Chianti Classico annata Chianti Classico Riserva Gran Selezione Sangiovese in purezza 55-56% 50-51% 85-86% Sangiovese+altre uve 44-45% 49-50% 14-15%
Come si vede la percentuale di chianti classico sangiovese in purezza è aumentata in ogni tipologia, anche se con dei distinguo importanti.
Se nella Gran Selezione (che comunque copre non più del 5% del totale di bottiglie prodotte) siamo quasi a percentuali “bulgare” e si potrebbe identificare totalmente la tipologia con il sangiovese, per quanto riguarda annata e riserva la situazione è molto diversa.
Tra i Chianti Classico d’annata poco più del 50% è sangiovese in purezza mentre per la Riserva c’è proprio una divisione precisa a meta, quindi con una bel numero di vini che arriva ad avere anche un 20% di altre uve, autoctone o no.

Percentualmente sono aumentati più i vini sangiovese in purezza nei vini d’annata che nelle riserva. Questa pare essere diventata il “luogo di raccolta” di chi vuole ancora usare le molte altre uve che esistono in Chianti Classico. Mi sembra quindi giusto puntare QUI il focus del discors.
Una differenza di uvaggio c’è indubbiamente tra i due vini da maggior invecchiamento della dbnominazione e viene da chiedersi come le UGA, che si basano solo sulla Gran Selezione, vino quasi completamente sangiovese in purezza, rappresentino realmente questa terra se l’altro vino da invecchiamento ha una composizione diversa, nonché un numero di bottiglie prodotte nettamente superiore? Non si rischia di presentare un’immagine non realistica del territorio, almeno fino a quando non farà parte delle UGA anche la Riserva?
Inoltre, avendo davanti l’esempio di Montalcino dove il cambio climatico non sta certo facilitando le cose, non sarebbe il caso di essere un po’ più elastici e di perorare, a livello consortile, il mantenimento di quelle uve che da molti anni caratterizzano, assieme al sangiovese, il territorio?