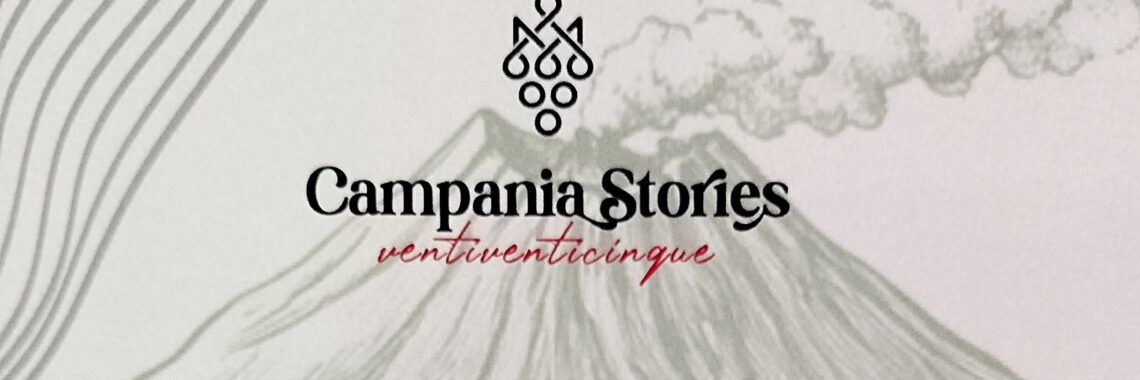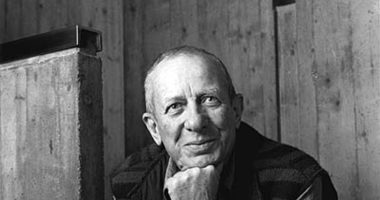Campania Stories 2025 mi piace racchiuderla tra una cattedrale nel deserto che funziona e un vulcano che, per fortuna, non funziona.
La cattedrale nel deserto è la stazione ferroviaria di Napoli-Afragola, nata praticamente in mezzo al nulla cosmico, ma che nemmeno tanto piano piano sta diventando lo scalo ferroviario principe per la Campania.
Il vulcano che per fortuna non funziona è il Vesuvio, mentre i vini che vi nascono funzionano e alla grande. Ma prima di parlare dei vini due parole sulla crescita generale di quella che potrei chiamare “La denominazione più veloce del mondo”.

Turismo del vino, comunicazione: DOC Vesuvio la vera sorpresa, con l’Irpinia che deve fare “mea culpa”
La prendo un po’ larga: quando si parla di vini campani il pensiero va quasi sempre a quelli irpini, Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Taurasi e ai molti bravissimi vignaioli che li producono. Ma produrre vino buono o ottimo ormai non può bastare, bisogna anche farsi vedere, organizzarsi per l’enoturismo, pensare a strutture ricettive, ma purtroppo molto spesso in Irpinia non c’è per strada nemmeno un cartello indicatore che porti alle cantine. Parlavo con un produttore e mi diceva che sono 5 anni che provano a fare una piccola mappa cartacea delle aziende di Castelfranci (dove ci sono “ben” 9 cantine) e ancora non hanno deciso niente. Lasciamo poi da parte i siti internet che non esistono o quasi, l’ospitalità (pur generosa) affidata al caso e comunque l’assoluta mancanza di coordinamento generale, dimostrata dall’assoluta inconsistenza dei consorzi di tutela. In altre zone va un po’ meglio, tipo nei Campi Flegrei, ma solo per iniziative e voglia di fare di singoli produttori che riescono a portarsi dietro gli altri.
Il vulcano non funziona ma i vini si.
Veniamo al Vesuvio, a quella zona sempre considerata secondaria nel panorama campano e che invece, da alcuni anni sta diventando, anzi è diventata un posto ideale per l’enoturismo: cantine moderne e accoglienti, personale che parla inglese, ristoranti aziendali dove si mangia pure bene, panorami mozzafiato, van aziendali per portare i turisti, visite in cantina accurate, professionali e amicali nello stesso tempo, magari utilizzando anche sommelier di alto profilo, megacantine in costruzione e soprattutto vini moderni ben fatti, ben pensati, ben presentati e naturalmente (quasi sempre) buoni.

Ti domandi se sei in Napa Valley e invece ti trovi nel comune di Boscotrecase, Somma Vesuviana, Ottaviano o in un degli altri dieci comuni che formano il Parco del Vesuvio. Tutto questo “Sistema Vesuvio” è nato e si è sviluppato in pochissimo tempo: non andrei oltre i 5-6 anni anche se diverse cantine hanno storia da vendere. La sorpresa infatti non è tanto la singola azienda ma appunto il “sistema Vesuvio” che ha quagliato attorno alle giovani generazioni di produttori e ha portato alla rapidissima crescita della denominazione più veloce del mondo.
Tutto questo, nei nemmeno 350 ettari vitati del comprensorio vesuviano, ruota attorno a vitigni non certo famosi, come il caprettone o la catalanesca, mentre tra i rossi domina il piedirosso, con una piccola parte dedicata allo sciascinoso e una, crescente, all’aglianico. Anche se il Vesuvio arriva ad oltre 1200 metri le vigne sono piantate da 50 metri fino a 650, anche se la maggioranza si trova nella fascia centrale tgra i 200 e 400 metri.

Il bello dei vini del Vesuvio è che non vogliono colpire per potenza o concentrazione (quindi se dio vuole non usano quasi masi i legni e se li usano lo fanno poco e bene). La freschezza e dinamicità di questi vini nasce anche e soprattutto dal terreno vulcanico, composto da sabbie finissime, ceneri e lapilli. Un terreno molto sciolto che permette anche di avere le viti su piede franco e porta a vini di spiccata sapidità. Se dovessi esprimermi sui vini metterei al primo posto i sorprendenti metodo classico (ma non sono molti), da caprettone o da piedirosso, poi i bianchi, i rosati e i rossi a chiudere il cerchio.
Campania Stories: la classica, eccezionale mosca bianca, anno dopo anno.
Ma adesso veniamo a Campania Stories 2025 nel suo complesso: la manifestazione è quasi una mosca bianca nel panorama nazionale perché riesce a mettere assieme molte ore per la degustazione con numerose visite sul territorio e incontri con i produttori. Non crediate sia un impresa facile! Sul fronte degustazione pubblicheremo tra qualche giorno i risultati degli assaggi dei bianchi mentre per quanto riguarda i rossi andremo a dopo l’estate. Come ormai sanno quelli che ci seguono non siamo di quelli che si divertono a sparare punteggi un quarto d’ora dopo l’assaggio, quindi faremo le cose con calma ma qualche anticipazione generale è d’obbligo. In generale l’annata 2024 non passerà certo alla storia: la scarsa o scarsissima piovosità è andata purtroppo a braccetto con temperature invernali molto miti che hanno portato a degli anticipi vegetativi tra i 10 e i 15 giorni di media.

I vini bianchi: 2024 non certo al top in tutta la regione
Sicuramente la situazione peggiore è nei bianchi e questo è un dato che tocca un po’ tutte le zone, da nord a sud della regione. Le tre uve principali, fiano, greco e falanghina si sono presentate con vini semplici al naso e poco reattivi al palato, solo i greco di Tufo ci hanno fornito un quadro leggermente migliore ma non c’è da fare salti mortali dalla gioia. Il caprettone ha dato discreti risultati, mantenendo nasi piuttosto freschi e una sapidità che ha sopperito all’acidità più bassa del normale. Sicuramente i terreni più sciolti, vulcanici, hanno permesso di lavorare con maggiore puntualità nel vigneto e comunque hanno creato meno asfissia radicale alle piante rispetto a zone argillose più compatte. Andando indietro negli anni le cose cambiano e, ancora una volta tra i Greco di Tufo in particolare, abbiamo trovato bianchi di altissimo profilo.
I vini rossi: pochi e poco convincenti i 2024 assaggiati, ma c’è il “miracolo” Taurasi
Sul fronte dei rossi 2024, visto che i campioni presenti erano ben pochi e quasi tutti a base piedirosso, sospendiamo il parere ma da quanto assaggiato ci sembra che non sia andata molto meglio dei bianchi: frutti maturi, freschezza claudicante, piacevolezza non certo alta. Una cosa però voglio dire sul vino rosso emblema della regione, il Taurasi: per la prima volta da quando li assaggio, e quindi si parla di quasi 25 anni, ho notato un chiaro cambio di stile con, specie nelle ultime annate (2021-2020-2019) una concventrazione tannica inferiore con tannini più dolci e gradevoli: a un certo punto ci siamo guardati in faccia e chiesto anche qualche parere a colleghi perché ci sembrava quasi impossibile che dopo anni che continuiamo a dire di estrarre meno e meglio dalle uve, si stia andando proprio in questa direzione.

E’ un cambiamento che va sottolineato e che spero cresca e non poco. Forse il merito è delle nuove generazioni che piano piano stanno facendo cambiare vecchie e rugginose idee ai genitori, forse è anche il mercato che oramai non può più aspettare vini spesso anacronistici, fatto sta che i Taurasi “giovani” hanno equilibri e rotondità impensabili fino a due anni fa, senza per questo perdere di identità.
In conclusione una Campania Stories che si conferma momento basilare e imprescindibile per la conoscenza della Campania enoica. Se “I miriadi” non ci fossero bisognerebbe inventarli a forse tanti produttori campani un piccolo monumento dovrebbero farglielo.