Sono anni che si parla di terroir, di MEGA, MGA, UGA, di valore unico del terroir, di come il terroir incida in maniera fondamentale in un vino. Conosco centinaia di produttori (e altrettanti magari li conoscete pure voi) che spergiurano, pure in buona o buonissima fede, che i loro sono vini di terroir, di microparcella addirittura, e che si differenziano in maniera netta da quelli della parcella accanto.
Gli ultimi arrivati nel campo delle MGA sono “Le Pievi” a Montepulciano, con lo studio sui terreni e sulle caratteristiche, naturalmente uniche e facilmente riconoscibili, che portano nei vini.

Non so se è la mia incompetenza (ma di solito non assaggio mai da solo) ma degustando vini che provengono dallo stesso terroir, UGA, MEGA, MGA mi ritrovo spessissimo davanti a prodotti completamente diversi, sia per caratteristiche analitiche che organolettiche.
Dirò di più, spesso l’unico “terroir” che si riconosce è la mano del produttore e nel recente passato (ma anche oggi) quella dell’enologo.
Non vorrei essere dissacrante o offensivo ma forse, in tanti casi, molti produttori italiani (forse anche di moltissime altre zone ma non ho la conoscenza per dirlo) non hanno ancora appreso il modo per traslare un terroir in un vino.

Purtroppo, solo dal punto di vista di questo “traslare”, la mano del produttore incide molto.
Vediamo però cosa io intendo per “mano del produttore”: considerando di lavorare su un monovitigno lascio da parte il tipo di clone, il portainnesto e la forma di allevamento, anche se “solo” in questi tre casi si trovano differenze enormi ma difficilmente quantificabili dal punto di vista organolettico. Parto così dalla potatura e passo a considerare solo macrooperazioni in vigna, come la sfogliatura o la non sfogliatura, il tipo e il numero di trattamenti e la scelta della data di vendemmia, riferendomi al punto di maturità fenolica e/o alcolica scelto dal produttore per raccogliere. Poi si arriva in cantina e qui partendo dalla pressatura (con o senza criomacerazione preventiva), passando al tipo di lievito utilizzato, arrivando a come viene condotta la fermentazione per poi giungere al momento della svinatura, tenendo ben conto di possibili macerazioni più o meno prolungate e arrivando poi alla maturazione/affinamento in contenitori di vario tipo e grandezza per tempi più o meno lunghi, chiudendo con le dosi di solforosa utilizzate durante questi passaggi e/o all’imbottigliamento, ti si presenta un quadro dove ogni scelta dell’uomo porta inevitabilmente a risultati diversi.
Anche uno solo di questi passaggi può portare a cambiamenti importanti, figuriamoci tutti assieme: ma soprattutto questi sono passaggi che un produttore non può evitare e anche il non intervento è comunque un intervento (penso ai cosiddetti vini naturali) che porta a risultati diversi.
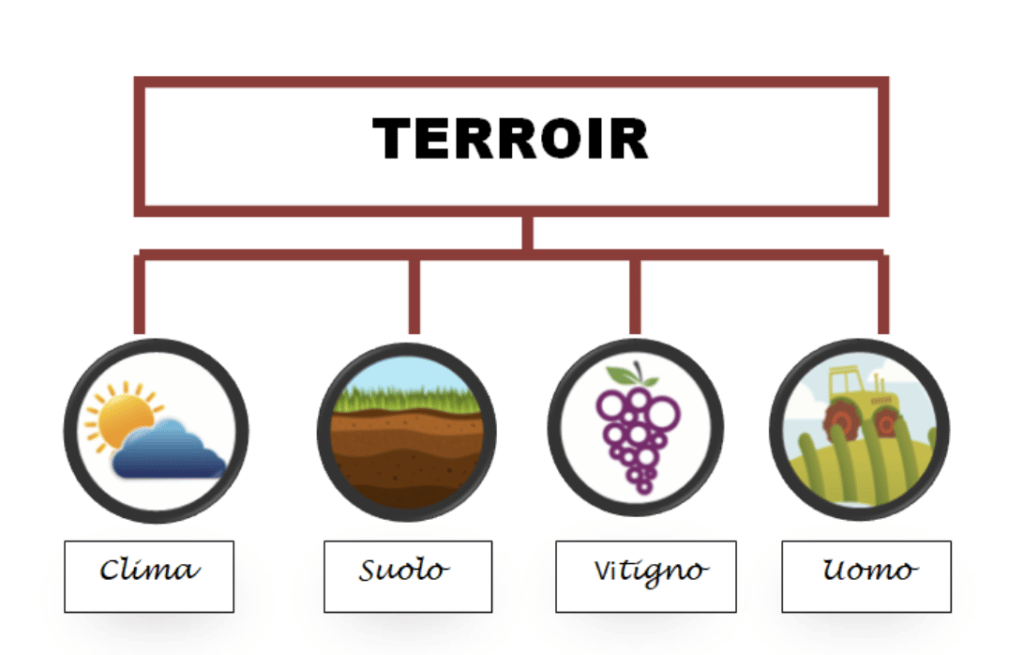
Così mi è venuta in mente una proposta, ammetto di difficile realizzazione, ma che potrebbe veramente portare a delineare meglio le caratteristiche dei vini di un certo terroir. I produttori di una determinata zona si ritrovano davanti ad un tavolo e si confrontano sui loro diversi modi di approcciarsi alla vigna e soprattutto alla cantina: infatti per me è soprattutto in questo luogo che il terroir perde le sue caratteristiche e prende “forma umana”, cioè quella che la mano del produttore gli conferisce.
Capisco che ogni produttore possa essere geloso dei suoi modi di operare e credo che in un confronto anche leale e reale alla fine ognuno possa rimanere sulle sue posizioni, ma questa sarebbe un’ implicita conferma che è realmente la mano del produttore a delineare e incidere sulle caratteristiche dei vini.
All’opposto, se si riuscisse a delineare una procedura omogenea che permetta alle caratteristiche di quel terroir di venire fuori in maniera chiara sia dai vignetoi ma soprattutto da x cantine, ecco che questo famigerato concetto troverebbe una strada condivisa per presentarsi nella sua chiara univocità e soprattutto nella netta diversità con tanti altri terroir.

Una volta Paul Pontallier, lo storico e compianto enologo di Chateau Margaux dichiarò che per lui “The terroir is not just the site. It is also the collective intelligence of those people who worked on that site”.
Io credo che se questa “intelligenza collettiva” venisse attivata e condivisa, anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, i produttori che sul quel terroir vivono non potrebbero che trarne vantaggio sia in reale riconoscibilità sia in diversità da altre zone. Ma la diversità, e di questo sono convinto, si fa almeno al 50% in cantina, attraverso una serie di scelte o di non scelte.
Questo andrebbe detto con chiarezza, anche vantandosene se vogliamo, perché alla fine l’intelligenza collettiva è frutto della fusione di quelle singole, anche di epoche diverse, che nascono sempre da esperienze diverse e quindi conducono a scelte che si ripercuotono sui vini rendendoli normalmente disuguali, anche quando si predica e si crede il contrario.
Insomma questa intelligenza collettiva, se veramente vogliamo parlare di terroir, deve formarsi anche e soprattutto tecnicamente, anche e soprattutto in cantina, cioè nel luogo cioè dove si fanno scelte che creano diversità ma sono vendute però come evidenti somiglianze.





