Fabrizio Dionisio mette in crisi la mia vecchia idea che ogni produttore (che fa realmente il suo vino) assomiglia al suo prodotto e viceversa. Fabrizio ha infatti un fisico filiforme, un portamento british e modi tra il timido e il molto educato per confrontarsi con gli altri, mentre i suoi Syrah, anche perché nascono a Cortona dove il caldo è ormai di casa, paiono a prima vista opulenti, grassi, solari.

Ho detto paiono perché se c’è una cosa che ho capito nella verticale di dieci annate del suo vino più famoso e importante, il Castagno, è che sembrano vini corposi ma in realtà sono Syrah eleganti. Sembrano essere caldi e ridondanti quando il clima è da annata sahariana (2003-2007-2012-2020-2022), quando anche Fabrizio magari si è lasciato andare al caldo perdendo un po’ del suo simpatico aplomb, ma quando il clima volge al fresco o all’annata più equilibrata (2005-2009-2013-2016-2019) ecco il carattere di Fabrizio marcare l’eleganza e la sobrietà dei suoi Syrah.
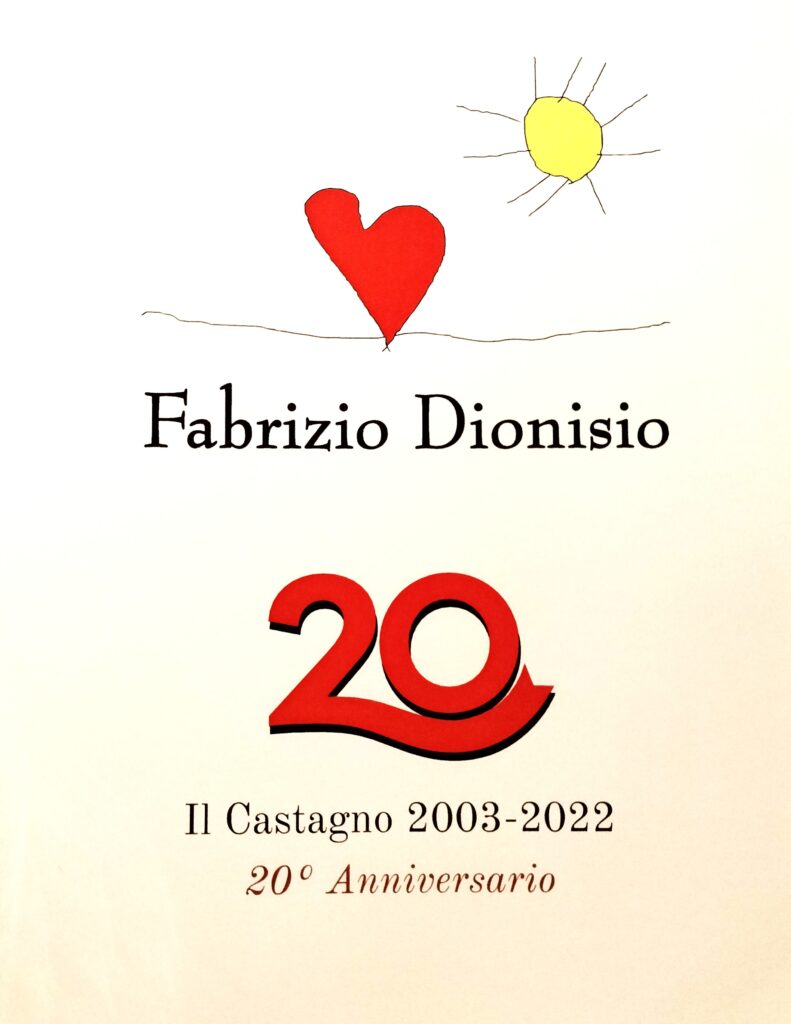
Come detto tutto questo e molto di più l’ho capito durante la degustazione di dieci annate del Il Castagno, dalla 2003 (prima annata prodotta) alla 2022, passando appunto quelle riportate sopra.
Chi mi conosce sa che non sono certo un amante dei rossi di Cortona, dove il Syrah domina, ma questa degustazione, a cui ha partecipato sia Stefano Amerighi, padre-non padrone, della denominazione che l’attuale enologo Valentino Ciarla e il suo predecessore, il mio amico Attiglio Pagli, mi ha fatto capire che quelli che non amo sono solo i Syrah giovani di annate calde e con tanto legno.
Infatti fino alla 2019 ho trovato vini di carattere ma mai con note alcoliche o di legno fuori quadro: il bello però l’ho trovato nelle annate fresche o equilibrate, dove la Syrah ha una marcia in più in finezza e complessità aromatica, ma soprattutto in eleganza e profondità gustativa. I tannini sono quasi sempre dolci, ma in annate come 2005 , 2013 e 2016 assumono note setose e il vino ha un allungo notevole.
Come accennato la prima annata è stata la 2003, con le vigne che erano di 3-4 anni e da allora più o meno i vini hanno seguito la stessa strada, smussando negli anni la permanenza in legno, puntando anche a legni più grandi e/o a vasche di cemento.

I risultati, oltre ad essere positivi, hanno un leit-motiv di tannicità dolce e equilibrio aromatico che non fanno certamente rimpiangere un’acidità classicamente non alta, compensata in alcune annate da una sapidità suadente.
Per quanto mi riguarda sono vini che danno più soddisfazione in bocca che al naso e sicuramente se Cortona si trovasse meno al centro del “ciclone” del cambiamento climatico i vini sarebbero ancora più profondi e complessi.
Prova ne sia la 2013, annata fresca/fredda, che dopo quasi un’ora nel bicchiere ha messo in mostra quelli che per me dovrebbero essere i profumi della Syrah: un misto tra spezie (pepe in primis), frutto maturo di bosco (mora in prima fila) con vene finemente animali. Profumi scapigliati ma di grande impattoche rappresentano bene questo vitigno dalla molte personalità: non per niente nel nuovo mondo ha anche un nome leggermente diverso.
Gli stessi profumi, ma con un po’ di maturità in più li ha mostrati la 2005, mentre la 2016 ha fatto vedere cosa può dare al palato la Syrah nelle grandi annate.
Fabrizio ha fatto benissimo ad organizzare questa didattica e profonda degustazione, a cui hanno partecipato una decina di bravissimi colleghi, rendendo la degustazione molto dinamica e vivace.

Torno da Cortona con molte più informazioni e belle sensazioni sulla Syrah, vino che secondo me, specie nelle sue espressioni di punta, va aspettato almeno 4-5 anni: detto questo credo che una via di mezzo, cioè Syrah da vendere giovani e dove il legno non incide o pochissimo, possano essere forse il modo migliore per avvicinare gli appassionati a questo territorio, a questo “paese che sta sulla collina, disteso come un vecchio addormentato” come cantavano nel lontano 1971 i Ricchi e Poveri a Sanremo, senza sapere di star parlando, appunto, di Cortona.




