Vulcania, rassegna dei vini prodotti su terreni vulcanici, è una bella idea ed è bene che vada avanti.
Sono tornato a controllare dopo 4 anni e sono rimasto soddisfatto.
Questa volta la location è stata Pitigliano, in un’ area crivellata da antichi crateri, sommersa da metri e metri di tufo. Le eruzioni catastrofiche avvennero in un’ epoca in cui non c’era nessuno: in confronto Pompei è roba da ragazzi .
I punti di riferimento locali erano Edoardo Ventimiglia, presidente del Consorzio Bianco di Pitigliano, e il problem solver Carlo Zucchetti , entrambi dello zoccolo duro di Arcigola, quando non si chiamava ancora Slow Food . Allora, nel Giurassico, combattevamo spalla a spalla.
La formula di Vulcania , oggi come ieri , si articola su due filoni: Culturale e Ricreativo, come nelle Case del Popolo di Benigni.
SI PRINCIPIA CON IL CULTURALE.
Anno dopo anno , a forza di parlarne , gli organizzatori del convegno, che nascono enologi, sono diventati vulcanologi esperti , che sanno tutto su tutti i vulcani italiani ( una sessantina ! ) e lo raccontano molto volentieri .
Poi ci sono o geologi e i vulcanologi veri , che ci aggiornano sullo stato dell’ arte vulcanologica .
Fra la messe di informazioni che ci hanno fornito , due mi hanno colpito più delle altre.
1) LO STRONZIO È L’ IMPRONTA DIGITALE DEL TERROIR . Il rapporto fra gli isotopi Sr 87 / Sr 86 è caratteristico di ogni sito e passa intatto nell’ uva e nel vino.
Viene alterato da certi trattamenti, ma soprattutto viene alterato quando si aggiunge alla vasca una cisterna di vino proveniente da altrove.
Non è proprio una novità: infatti ve l’ ho segnalata nel resoconto di Vulcania 2009. Ma allora era una tecnica d’ avanguardia proposta dal prof. Conticelli , che andammo a cercare , nel suo laboratorio, qui a Firenze , in un luogo quasi segreto . Vedi “ L’ Epifania dello Stronzio “ .
Oggi è una pratica di routine , e ci fa piacere averne visto e segnalato subito le potenzialità.
Carlo Macchi, nel suo commento allo scoop, si chiedeva quanti milioni di euro avrebbe guadagnato l’ autore di questa scoperta . Una risposta indiretta l’abbiamo avuta a questa edizione di Vulcania: nella relazione sullo stronzio il prof Conticelli non è stato neanche nominato.
2) LA PADANIA È AFRICA!
Troppo forte! Avete presente la tettonica a placche ? sicuramente sì . Ebbene , nella sua danza lentissima, da milioni di anni la placca africana preme sulla placca europea, spostandola e finendole sotto. Ma il gioco avviene con reciproche manovre avvolgenti, il cui risultato è una posizione sinuosa, che ricorda il simbolo dell’ armonia universale Jing-Yang .
Il mar Tirreno e tutta l’ Italia Tirrenica fino all’ Appennino, dalla Liguria alla Sicilia , sono Europa – mentre l’Adriatico e più su fino alle Dolomiti, e a ovest quasi tutta la pianura Padana , fanno parte della placca Africana!
Ce l’hanno spiegato a Vulcania, perché proprio lungo il confine fra le due placche si sono formati tutti questi vulcani.
SOSPENSIONE DEL CULTURALE , PRINCIPIA IL RICREATIVO.
Ossia gli assaggi , le degustazioni, le gozzate a garganella.
Vi elenco una sequenza random di impressioni.
a) Effettivamente i suoli vulcanici danno di più ai vini bianchi . Era l’ idea iniziale di Vulcania ,
che, nel 2009 aveva il sottotitolo “tutti i colori del bianco” . C’è lo ricordava Lorenzon
presidente del consorzio Soave e nume protettore del convegno .
La presente edizione ha messo in mostra anche un po’ di rossi , che non hanno contraddetto la premessa .
Non significa che siano poco interessanti . Nella rassegna vulcanica è bene che ci siano.
Come nel caso del Piedirosso – Pierepalommo , un vitigno e una famiglia di vini che mi ispirano grandissima simpatia, perché apprezzo i vini di pronta e facile beva, che mi fanno felice senza darmi problemi – ma la personalità di vini da piedirosso è data dal frutto, più che dai minerali estratti dal suolo .
C’erano tre esemplari di Etna rosso, da uva nerello mascalese e cappuccio.
Promettevano molto all’occhio e al naso, ma in bocca tutto si è confuso , per l’ eccesso di legno .
Mi piacerebbe che il nerello ricevesse un trattamento più umano, senza prenderlo a legnate con tanta foga . Chissà se non si scoprirebbe un altro fratello dei vitigni che più amiamo .
b) Fra i bianchi sono andato ad assaggiare i vini e i vitigni che frequentiamo di meno.
C’era un solo esempio di vino da Durella , ma mi ha colpito. Spumante metodo classico pas dosè di grande carattere, intenso al naso con l’ effluvio dei lieviti, intenso in bocca ,con grande ampiezza di sensazioni minerali sostenute dall’ acidità austera , ma non tagliente . Vendemmiato nel 2006, sboccato nel 20012 . Prodotto da Fongaro , Lessini Durello DOC .
Il biancolella D’Ambra è ancora e sempre lui, quello che assaggiai in loco molti anni fa ( quando Arcigola non era ancora Slow Food ), guardando dall’ alto il vigneto scosceso sul mare di Ischia e di Capri .
Fontana Candida ( Luna Mater ) continua a spiazzarci, perché ancora, dopo anni, il nostro subconscio continua a rifiutare che un Frascati possa essere un grande vino .
Qualcosa del genere mi è successo anche con i Lacryma Christi di De Falco e di Romano Fioravante , che mi son sembrati troppo buoni rispetto all’ archetipo e davvero segnati fortemente dal suolo vesuviano .
Il Serprino , dei Colli Euganei, mi ispira simpatia per il nome arguto, che fa pensare a una maschera della commedia dell’ arte . A parte questo, i vini che se ne ricavano, sono un po’ troppo semplici .
Sul Soave e il Gambellara, come sul Bianco di Pitigliano ho assaggiato a campione, per star tranquillo che tutto procedesse per il meglio .
Rivisitare i soave di Cantina Monteforte ,Tenuta Solar e Le Battistelle mi ha tranquillizzato. Anche Ildebrando, colonna portante del bianco di Pitigliano, rimane una certezza.
PER CONCLUDERE , NULLA OMETTENDO (o quasi).
la degustazione iniziale, di 14 vini prescelti per i giornalisti, mi ha lasciato in sospeso un interrogativo. Lo rivolgo all’ ottimo Giovanni Ponchia che guidava la degustazione con grande sapienza geologica e che ci assiste perfettamente quando andiamo ad assaggiare a Soave .
Domanda : può la Garganega simulare perfettamente un Sauvignon?
Evidentemente sì , se il produttore dichiara il 100 % di Garganega e se il Consorzio del Soave lo sceglie per farsi rappresentare.
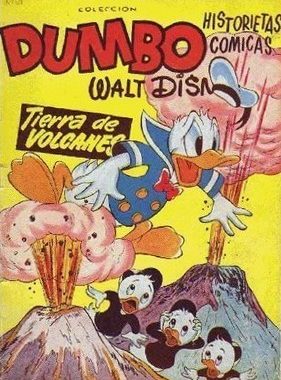





 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 