Croce e delizia, il grado alcolico nel Primitivo è sempre stato una discriminante tra chi lo ama per il suo impatto potente e chi invece gli rimprovera l’eccesso alcolico. Per quanto l’alcol possa ben integrarsi e non farsi sentire un elemento dominante, è innegabile che una gradazione alcolica alta come quella che si riscontra nei primitivi non lascia il consumatore indifferente, specie quando dopo averne bevuto qualche bicchiere tenta di alzarsi dalla sedia.
Se negli ultimi anni molti degustatori, hanno dato relativa importanza a questo dato la stessa cosa non avviene sui mercati esteri dove vini di siffatta alcolicità trovano qualche difficoltà ad affermarsi. Complice di ciò anche una campagna mediatica criminalizzante verso l’alcol in generale, che non fa distinzioni tra vino e superalcolici. Ma alla natura, si sa, non si comanda, specie quando i vini sono il frutto di un territorio solare che si esprime con estrema spontaneità. Ovvio quindi che vini con queste caratteristiche siano destinati a fasce di consumatori molto esigue e non potrebbe essere diversamente visto anche la produzione contenuta.
Ma l’elevato grado alcolico del Primitivo non è l’unico elemento che in qualche modo ne condiziona la diffusione: c’è anche la sua durata nel tempo.
Una delle caratteristiche del vitigno è quella di esprimere un frutto concentrato ricco di sostanze polifenoliche ma povero in particolare nei tannini. Se poi si aggiunge che per forza di cose, quando la maturazione appena appena viene spinta un po’ oltre l’acidità può essere compromessa, allora si spiega la non longevità del Primitivo in generale. Ovviamente esistono le eccezioni, ma in generale sono queste le caratteristiche del vitigno.
Allo stato attuale non c’è uno storico presso le aziende con cui confrontarsi e quindi in realtà, come avviene in buona parte del Sud Italia, nessuna sa come questo vitigno, anche coniugato nelle sue espressioni territoriali (Manduria, Gioa de Colle etc… ), possa esprimersi nel tempo. Le tecniche colturali possono in qualche modo influenzare il suo carattere ? Le pratiche di cantina (non invasive) possono determinare un profilo organolettico anche diverso da quello attuale? Forse sì a quanto ci è dato di sapere dalle notizie che arrivano dai vari istituti di ricerca che si occupano del vitigno.
Nei prossimi mesi ci occuperemo più specificatamente del Primitivo e proveremo a saperne di più su questo vitigno organizzando una serie di degustazioni verticali (delle aziende che hanno storia e che si dichiareranno sono disponibili) che ci daranno, speriamo, notizie più certe.


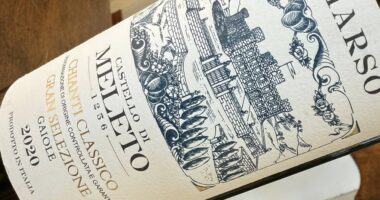



 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 