Non è l’ennesima sortita di Gianni Minà, è il decennio della prima significativa svolta nell’enologia in Maremma, come del resto in tutta Italia.
Sono gli anni in cui escono e crescono come funghi le Cantine Sociali. A Braccagni ne costruirono una nuova e grandissima che uno si chiedeva quale uva c’avrebbero portato. Astutamente fu battezzata Cantina Sociale di Montepescali, mica di Braccagni, così uno poteva pensare che il vino si faceva in collina.
Poi però furono fatte le vigne anche nel padule (nella piana paludosa n.d.r.)! Dove ti giravi e dove vedevi filari di viti.
Fu in quegli anni che arrivò l’enologo, figura prima sconosciuta, poi aberrata, poi accettata come una benedizione, e poi da ultimo fin troppo osannata.
Era l’epoca in cui si diceva che il vino (riferendosi a quello delle cantine sociali) “Li lo fanno con le bustine, io invece lo prendo dal contadino che lo fa con l’uva”.
Salvo che poco dopo i contadini cominciarono a presentarsi timorosi e circospetti “dall’egogolo”, così veniva chiamato, per dirgli: “Sa, c’è un mio amico che vorrebbe fare l’analisi di questo vino” e gli porgevano una bottiglia tutta incartata per non far vedere agli altri cosa c’era dentro. “M’ha detto anche di dirgli se ci può scrivere quello che secondo lei ci vorrebbe”. Nonostante l’egogolo capisse di chi in realtà era il vino, mangiava la foglia e diceva: “Guardi, gli dica al suo amico che deve fare questo e quest’altro: metabisolfito tot, acido citrico tot, poi travaso, poi questo e quello, e poi se il suo amico vuole, mi riporta il campione tra un tot”.
Si deve dire però che questi erano i migliori produttori, non i peggiori, perché pur con vie traverse sentivano la necessità di cambiare qualcosa.
I peggiori erano quegl’altri, che facevano “Il vino del contadino fatto con l’uva” e che continuava ad essere un vino bevibile all’inizio e una cosa assai meno dignitosa dopo.
“Il vino con le bustine lo sento subito io, mi fa venire un cerchio alla testa….”
Magari era il vino di uno che metteva il metabisolfito a spanne oppure a occhio, perché si vergognava a chiedere maggiori dettagli all’egogolo sull’esatta quantità e modalità di somministrazione.
Oppure: “Mai mischiare e bere nello stesso pasto un vino bianco e un vino rosso, è mal di testa assicurato!”
Ce n’è voluto di tempo, e non tutto si è sistemato. Si è dovuto attendere l’86 e lo scandalo del metanolo per avere la svolta decisiva. Ma questa è un’altra storia.
Nel frattempo le vigne con le rese fino a 300 quintali per ettaro furono espiantate e si cercò di fare il vino come si deve. Furono stavolta dati i premi alle vigne che venivano espiantate quando una ventina di anni prima i premi erano stati dati per impiantarle. E le cantine sociali più marginali chiusero una dopo l’altra.
Come per altre zone anche più blasonate si è dovuto aspettare che venisse qualcuno da fuori a dare le buone norme per migliorare.
Si cominciò con il Morellino di Scansano, il primo maremmano a farsi un nome in tutta Italia come vino della Maremma. Un bel passo in avanti: la prima DOC (da uve rosse) della provincia, quello che a me pare un vino molto buono anche se con poca tipicità, nel senso che difficilmente sono paragonabili due vini della stessa zona DOC. Forse per la vastità e la diversità della zona: basta pensare che si va dalle alte colline di Scansano fino a quelle dolci dell’Alberese, quasi in riva al mare……….qualcosa ci dovrà pur essere di diverso.
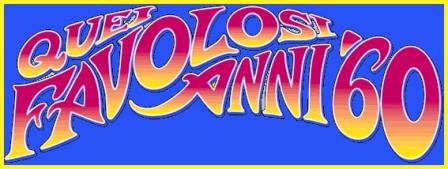


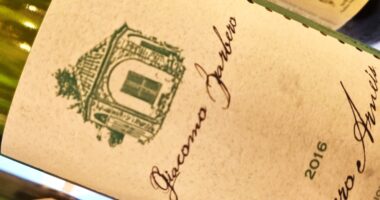



 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 