I dati proposti dal convegno fiorentino sul costo reale di una bottiglia di Chianti Classico e riportati qui in maniera asettica dal nostro Pierlorenzo Tasselli stimolano delle riflessioni non da poco.
Riflessioni che assumono subito un peso notevole se si parte dalla fine del percorso, cioè da quanto io, consumatore finale, pago in enoteca una bottiglia di Chianti Classico: Mediamente attorno ai 16-17 euro. Di questi 16-17 euro, da quanto è uscito dal convegno fiorentino, solo (se va di lusso…) circa 3 spettano al valore del vino nella bottiglia. In termini desueti: il valore creato dall’agricoltore con il suo lavoro è di (abbondiamo) 3 euro mentre il plusvalore e tutte le strutture pesano per i rimanenti 13-14.
Ne vogliamo parlare? Prima di parlarne però vediamo anche a quale prezzo questa benedetta bottiglia di chianti classico dovrebbe essere venduta dall’azienda per guadagnarci qualcosa: la cifra è di (per l’annata 2009) 6.46 € ma purtroppo la media reale di vendita è molto più bassa e si attesta a 4.93€. Lascio da parte il prezzo medio dello sfuso (1.71!!! per un chianti classico) perché avrebbe bisogno di un discorso a parte e torno a bomba.
Si sostiene, forse anche giustamente, che il vino è caro e che questo è uno dei motivi per cui se ne beve sempre meno. Niente da eccepire, specie se vai a ristorante e per una bottiglia di vino non certo eclatante ti ritrovi a spendere da 20 a 25 euro. Se siete in due il prezzo del vino grava spesso quasi come quello di un terzo commensale. Ora, mettiamo che a ristorante, in due, vogliate bere una bottiglia di Chianti Classico: ad andare bene spenderete 20-25 € per un prodotto che, in natura ed al produttore, costa meno di 3€, quindi quasi il 15% del prezzo da voi pagato.
E’ possibile che non si possa fare niente per cercare di rimpicciolire questo moloch del 80% che pesa come un macigno sul mondo del vino? Sono d’accordo che, per equità si dovrebbe anche fare uno studio serio sui costi di commercializzazione e distribuzione ma non si può negare, avendo davanti questi dati, che l’agricoltore è quello che in questa filiera non solo guadagna meno ma soprattutto ha i margini minori per poter diminuire i prezzi. Per questo l’agricoltore che non vuole fallire deve fare anche il venditore e il distributore del suo prodotto.
Nello studio si parla di Chianti Classsico ma credo che le percentuali rilevate siano riscontrabili anche in altre denominazioni. Magari cambieranno i prezzi ma i rapporti, più o meno, rimangono invariati.
Avendo parlato di questi temi con amici ho fatto la figura di quello che scopre l’acqua calda: “Ma lo sanno tutti che il costo maggiore è sempre quello della distribuzione!!” mi sono sentito dire più volte. Va bene, questo lo sapevo, ma non pensavo che fosse così alto e che mettesse il reale motivo per cui uno compra una bottiglia di vino, cioè il vino, in una posizione talmente defilata, assolutamente minoritaria e quasi ininfluente sul costo finale della bottiglia.
In realtà e questa è la cosa brutta, a cui è difficilie abituarsi, a cui non è facile dare un senso se i numeri sono questi: quando compriamo un chianti classico (ma anche altri vini, come detto) acquistiamo bottiglia, etichetta, tappo, marketing, distribuzione, commercializzazione, pubblicità E ANCHE 750 grammi di un prodotto della terra chiamato vino. Il primo motivo dell’acquisto diviene, in ordini di costo, praticamente l’ultimo. Il cosiddetto valore aggiunto di una bottiglia di vino diviene il vero valore, mentre il vino è schiacciato in un angolo. “E’ la stampa , bellezza!” ma questa "stampa" (e questi sono i numeri)non fa certo il bene di chi il vino lo produce VERAMENTE.
Il bello è che marketing, commercializzazione, pubblicità, praticamente tutta la “sovrastruttura”, si rifanno solo a quella parte minimale, a quel prodotto che in termini percentuali varia dal 15% al 20% , ma che il rimanente 80-85% presenta come se contasse il 100%. Non vi sembra strano? Non vi sembra ci sia qualcosa da cambiare in tutto questo, e quando parlo di “tutto questo” non mi riferisco solo al Chianti Classico ma a tutto il mondo del vino.
Mi è capitato sott’occhio un ‘articolo sopra un convegno con temi enoici organizzato dal Monte dei Paschi di Siena. L’articolo sottolineava che i risultati di uno studio commissionato dalla banca stessa si augurava (per non dire che lo vedeva come unica soluzione) l’aumento del marketing e della pubblicità. Non della qualità del prodotto finale (data sempre per scontata, troppo per scontata) ma di una parte del resto, della quota dell’85%: a scapito di cosa?
Facendo parte del 80-85% capisco di darmi la zappa sui piedi, ma un mondo definito agricolo dove il prodotto agricolo NELLA REALTA’ conta percentualmente meno di molte altre voci, rischia di perdere di vista il vero valore; quello del miglioramento (o della salvaguardia) della qualità proprio di quel prodotto da cui tutto nasce.
Parlavo con un importatore brasiliano che, di fronte all’etichetta di un vino toscano mi diceva “Sai cosa si vende da noi? La scritta “Toscana”, poi può essere più buono o meno buono, basta che abbia il nome.” Esempio lampante di come il “grande 80-85%” veda il piccolo 15-20%: un nome su un’etichetta.



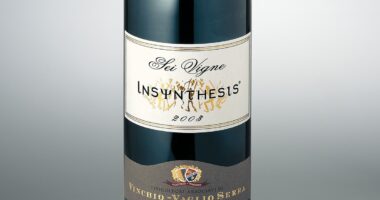


 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 