In principio fu la Nuova Zelanda. Agli inizi degli anni novanta i Sauvignon prodotti nella zona di Marlborough venivano osannati come figli di un terroir particolare, unico, che concedeva aromi allora impensabili, con note che non si fermavano ai classici profumi vegetali, di peperone o addirittura all’italianissima pipì di gatto, ma spaziavano verso orizzonti incredibili, arrivando fino al pompelmo e al frutto della passione.
Fior di giornalisti internazionali inneggiarono a questo terroir baciato da dio, salvo poi scoprire che non di questo si trattava ma molto più semplicemente di un sistema di vinificazione che permetteva a delle sostanze aromatiche presenti nella buccia del Sauvignon di liberarsi in quantità industriali. Volgarmente e genericamente vengono chiamati tioli ma quelli che, se giustamente titillati, esprimono vagonate di aromi pompelmati e fruttopassionati si chiamano: 4-mercaptometilpentanone (4-MMP) e 3-mercaptoesanolo (3-MOH).
Questi signori, pur trovandosi da sempre nelle cellule della buccia giacevano tranquillamente nella loro “tomba” enoica fino a quando, con sistemi che si possono rozzamente definire col termine “iperriduzione” (che ha bisogno di temperature basse, assenza o quasi di contatto con l’ossigeno in tutte le fasi della vinificazione, utilizzo di sostanze come enzimi o lieviti che stimolano la loro fuoriuscita in grosse dosi etc.) non vennero svegliati dal loro sonno, portati nel mosto e da lì nel vino finito a “miracol mostrare”.
Tutti d’accordo nel considerare questo un grosso passo avanti per la vinificazione del sauvignon, anche perché di un passo avanti puramente tecnico si trattava e quindi esportabile in tutto il mondo…purtroppo.
Se fossimo stati in un film horror la fase neozelandese avrebbe potuto avere come nome “Non aprite quel tiolo”. E Come in ogni film dell’orrore che si rispetti l’arrivo del metodo per dare vita al tiolo ha avuto prima solo alcune apparizioni, presenze passate quasi sotto silenzio: un catarratto qua, un vermentino là, per poi arrivare alla “notte in cui tutti i tioli uscirono dalla tomba, pardon dalla buccia” …. ma andiamo con calma.
Il bello ( o il brutto…dipende) dei nostri 4-MMP e 3-MOH, nonché di alcuni fratelli dai nomi altrettanto difficili è che sono stati trovati anche in altre uve a bacca bianca. Sicuramente l’elenco è incompleto ma si ritrovano nel verdicchio, nella garganega, nel vermentino, nel catarratto, probabilmente nel friulano e…naturalmente nel Sauvignon.
Per questo motivo stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione aromatica che colpisce una bella fetta dei bianchi italiani. Basta che una cantina si doti di una tecnologia neanche tanto costosa ed ecco spuntare pompelmi e frutta della passione in vini che fino a ieri mostravano fini note floreali oppure frutta bianca. Il bello è che questi aromi tiolati coprono completamente gli altri, presentando così un panorama di bianchi praticamente omologati dall’Alto Adige alla Sicilia. Poco importa che i nostri tioli usciti dalla buccia, non siamo molto stabili e tendano a deperire facilmente, nei primi mesi di vita di quel vino lo marcano in maniera indelebile.
Abbiamo iniziato da pochi giorni ad assaggiare i bianchi del 2012 e la situazione è chiara: pompelmi nel Soave, nel Vermentino ligure, nel verdicchio…e abbiamo ancora la stragrande maggioranza dei bianchi davanti a noi.
Ora, per non essere tacciato di osteggiare lo sviluppo della scienza faccio un passo indietro. Cinquanta anni fa i bianchi che ho citato (nonché molti altri) non avevano certo, tioli a parte. i profumi di adesso. Spesso raggiungevano velocemente note di buccia di mela matura perché si ossidavano in fretta; è stato solo grazie alla tecnica che si è potuto permettergli di vivere una vita di soddisfazioni (per noi ovviamente).
Mi ricorderò sempre del Trebbiano o della Vernaccia di san Gimignano che producevano negli anni sessanta contadini in zona. Vino giallo perché vinificato con le bucce e con profumi dove quello di buccia di mela era di gran lunga il migliore (assomigliavano a tanti vini cosiddetti naturali di oggi, ma questo è un altro discorso). Dato che ben pochi avevano il coraggio di berli, regolarmente venivano messi nel pastone degli animali da fatica quando si ammalavano.
Da allora il mondo dei bianchi italiani ha fatto passi avanti da gigante e se alcune omologazioni aromatiche ci sono state diciamo che era un dazio da pagare.
Oggi però la situazione è diversa: i nostri cari tioli rischiano di far perdere la testa al consumatore, che si ritrova valanghe di aromi indubbiamente piacevoli, netti,potenti e facilmente riconoscibili in vini IGT-DOC e DOCG di varia provenienza. Questi aromi ottenuti a buon mercato, possono portare a maggiori fette di mercato e invogliare sempre più produttori a seguire quella strada.
Tutti liberi di farlo per carità, ma poi non lamentiamoci se la Cina ci fregherà grosse fette di mercato producendo ad un quarto dei nostri prezzi vini che strabordano di pompelmo e frutto della passione. Non lamentiamoci se ci verrà rinfacciato una mancanza di tipicità. Non lamentiamoci se per tornare indietro verso una maggiore caratterizzazione territoriale ci vorranno anni di lacrime e sangue. Non lamentiamoci se, parlando di terroir italiani, tanta gente dalla Francia in giù si metterà a ridere sguaiatamente.
Non lo nego: i vini fatti in iperriduzione mi piacciono e li bevo anche volentieri ma di fronte al dilemma che noi di winesurf ci poniamo “Questo vino è rispondente all’uva da cui proviene?” mi trovo in difficoltà.
Vi prego, aiutatemi!
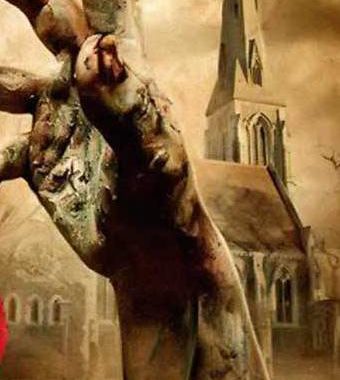






 © 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526
© 2016. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - LA LANTERNA MAGICA. VIA DELLA REPUBBLICA 10. 53036 POGGIBONSI (SI) TEL/FAX 0577981652 - P.IVA 01072300526 